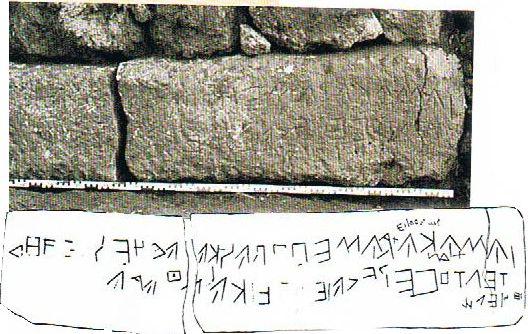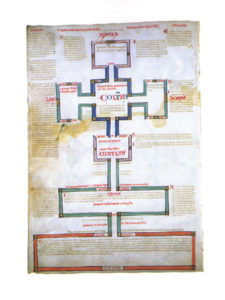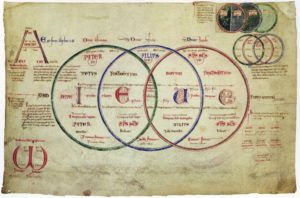GLOSSARIO ETIMOLOGICO DELLE LINGUE ANTICHE.
PREFAZIONE
Nel saggio “Dalla Scania alla S(i)cania”, pubblicato nel 2011, si avanzava l’ipotesi che la lingua parlata dai nostri Avi Sicani, avesse affinità con quella parlata dalle popolazioni del nord Europa, con quella protogermanica nello specifico. Questa convinzione è maturata grazie alla constatazione che tutto ciò che ruotava attorno all’arcaico centro religioso di Adrano, – luogo in cui sorse il tempio dedicato all’omonimo capo della stirpe sicana– dalla mitologia alla toponomastica, dalla idronomia alla simbologia, afferiva alla lingua parlata nei paesi del nord Europa. Utilizzando, dunque, la lingua germanica, che trova nell’attuale lingua tedesca una maggiore corrispondenza, traducemmo facilmente, non essendo la lingua germanica sostanzialmente mutata nel corso dei millenni, le celeberrime epigrafi ritrovate nel territorio adranita tra cui la tanto celebrata “Stele del Mendolito” e alcune di quelle dette anelleniche. Nel corso delle ricerche linguistiche, che durano tuttora, consultando i numerosi testi antichi facilmente reperibili: la Bibbia, i Veda, l’Avesta, l’Iliade etc. ci siamo accorti che in essi, non solo era evidente che le azioni compiute dagli uomini erano intersecate da riferimenti religiosi, metafisici, ma in essi si conservavano evidenti tracce di una lingua primordiale comune, lingua riconducibile al protogermanico, sebbene il protogermanico sia una lingua ricostruita scientificamente, può considerarsi con verosimiglianza, la lingua parlata originariamente dai popoli germanici. Sulla base di quanto sinteticamente qui affermato, fummo in grado di compilare un glossario etimologico in cui davamo a un certo numero di nomi, un significato che fino a quel momento era sfuggito ai linguisti, pur essendo i nomi in questione nati dalla apposizione di palesi attributi al fine di evidenziare le peculiari caratteristiche dei luoghi o personaggi descritti. Il glossario etimologico, dato alle stampe nel 2016, lasciava fuori, tuttavia, per l’impossibilità di contenerli al suo interno, un elevato numero di significativi nomi dei personaggi e dei luoghi citati nella storiografia mondiale. Il significato dei nomi, alla nuova luce con cui sono da noi stati decriptati e proposti ai lettori, assurge altresì a veicolo di storia portatrice di conoscenze su vari livelli. Si tratta, spesso, di un sapere raccontato con l’ausilio di metafore ad una stirpe che, parlando un linguaggio comune, meglio comprendeva il senso del racconto a noi oggi oscuro. Volendo rimediare al vuoto rimasto nel glossario pubblicato nel 2016 e fruibile gratuitamente attraverso questo link, avvalendoci questa volta di studiosi, che, incuriositi della nuova proposta interpretativa si sono a noi accostati, intendiamo colmarlo proponendo, di volta in volta, con la seguente modalità, il significato di alcuni attributi apposti ai personaggi e ai luoghi mitologici , con lo scopo, non secondario, di stimolare una più ampia gamma di ricercatori, linguisti, etimologi a verificare quanto da noi proposto e colmare le eventuali lacune linguistiche da noi, non specialisti del settore, inevitabilmente procurate.
PREMESSA.
Per una maggiore comprensione del metodo interpretativo da noi applicato che, come affermato, si richiama alla lingua proto germanica, risulta doveroso fare alcune premesse. Due poeti dell’ VIII sec a.C., Omero ed Esiodo, fanno cenno alle caratteristiche somatiche dei personaggi oggetto della loro disquisizione. Le caratteristiche somatiche da loro descritte riferendosi a eroi e divinità greche, fanno inequivocabilmente riferimento a quelle medesime che si riscontrano tra gli abitanti del nord Europa. Quelle caratteristiche, oggi meno evidenti a motivo dei matrimoni misti praticati per millenni, erano ancora molto evidenti ai tempi dello storico romano Tacito e, nonostante il tempo trascorso, ancora oggi rinvenibili fra Scandinavi ed Irlandesi. Ciò viene segnalato al fine di mettere ulteriormente in evidenza la compatibilità della tesi da noi elaborata circa le origini di una lingua che migrò, sulle gambe degli antichi popoli nordici al sopraggiungere di condizioni climatiche invivibili in quell’area geografica; migrazioni che si verificarono unilateralmente da nord verso sud. Gli spostamenti di centinaia di migliaia di uomini provenienti dal nord Europa, si verificavano ancora in tempi storici, scanditi da intervalli di tempo relativamente brevi. Basti ricordare la migrazione gallica del 390 a.C., che procurò a Roma gravi problemi essendo stata sottoposta a rapina e messa a ferro e fuoco da Brenno, il cui appellativo significa l’incendiario, dal verbo tedesco brennen, bruciare; seguì quella di Cimbri e Teutoni alla fine del secondo secolo a.C., poi ancora quella dei Goti nel V della nostra era ed ancora durante il Medioevo. Omero, in particolare, conscio della presenza di una popolazione pre greca nella penisola, che l’aveva informata della propria cultura, ancora avvertita ai suoi tempi, si limita a far cenno della presenza di vocaboli il cui significato è imperscrutabile e tuttavia percepito come inviolabile e inalienabile, tanto da lasciare convivere il vocabolo greco con quello barbaro che, anzi, viene inteso come appartenente ad una lingua parlata da dèi (Odissea lib. X, 305; Iliade, XIV, 290).
Il poeta Esiodo nella sua opera: “Lo scudo di Eracle”, si lascia andare ad una descrizione particolareggiata della bellezza di Alcmena, la madre mortale di Ercole alla quale neanche il Cronide seppe resistere. Ebbene, gli occhi di Alcmena erano di un azzurro cupo ed Esiodo, paragonandola “all’aurea” Afrodite intende indicare i suoi biondi capelli. Nei passi successivi il poeta di Ascra, descrivendo il bellicoso atteggiamento del semidio, che attende l’adirato fratellastro Ares a cui uccise il figlio Cicno, lo paragona ad un leone con “Una terribile luce negli occhi cerulei”.
Abbiamo ancora notato che il significato dell’appellativo si trova di solito già tra le righe del mito raccontato, secondo una tecnica escogitata dagli stessi poeti, della quale abbiamo già parlato altrove e metteremo ancora in evidenza in questa sede. Infatti, di questo metodo o tecnica adottata dai poeti dell’epoca, particolarmente evidente nell’Avesta, è stata fornita la chiave di accesso nel saggio “La lunga notte. L’Occidente i Veda e la trilogia delle razze umane” pubblicato nel 2013 e gratuitamente consultabile da questo link
CONCLUSIONI.
Il nostro lavoro sulla lingua nasce da un inarrestabile moto interiore atto a ristabilire una comunione tra l’uomo antico e l’uomo moderno. Nell’evidente antitesi tra i due modi d’essere, “l’evoluzione” della lingua parlata ha giocato un ruolo non certo secondario, al punto da rendere incomprensibile il significato di parole che, pronunciate nella sua corretta forma originaria, rappresentavano un atto di creazione. Affermava Erodoto, che gli dèi vennero in qualche modo soggiogati dopo che gli uomini diedero a ciascuno di loro un nome. La parola, dunque, cattura, imbriglia, conferisce una forma, crea l’oggetto a cui essa si riferisce. È come se l’oggetto prima invisibile, libero venisse d’un tratto scoperto e si arrestasse nel suo moto disinvolto. Così fu possibile, secondo la versione della genesi, creare l’increato, attraverso la pronuncia del “Verbo”. L’uomo, nel racconto biblico diede nome agli oggetti e agli animali, e divenne padrone di essi.
A
- ABANO. Abano Terme è una città italiana molto rinomata per la presenza di acque termali. Il toponimo risulta formato dal prefisso ab da, che indica provenienza, e Ano avo, antenato, cielo. Traducendo verbum pro verbo il toponimo, si ha la seguente trascrizione: dal-cielo o dagli-antenati. Il riferimento potrebbe avere come oggetto il dono delle acque curative, di cui già i Romani facevano largo uso.
- ADORARE. È possibile individuare nel verbo ad-or-ar il lessema hör che significa ascolto, ma, come più volte affermato, in una accezione metafisica. Il verbo italiano dunque, sarebbe derivato, dal momento che in greco non esisteva il concetto di ad-orare, da un lessico germanico: ab hör, da-ascolto. L’orante, nel domandarsi la provenienza (da = ab) delle percezioni extrasensoriali di cui egli era oggetto, si poneva in pari tempo, nei confronti dell’entità percepita, con un atteggiamento di reverenziale timore e ascolto.
- ADRANO-A. Il nome Adrano indica contemporaneamente un teonimo, un toponimo e un idronimo. Infatti esso si riferisce alla divinità sicula Adrano, alla cittadina siciliana in cui era stato edificato il tempio in suo onore, a quella spagnola, al fiume germanico citato dallo storico Tacito e quello attuale che scorre in Spagna nei pressi della città omonima. Riferito ai fiumi, l’idronimo ne indicherebbe la “furia” con cui essi scorrono nei loro alvei. Riferito alla divinità invece, né indicherebbe l’aspetto terribile con cui avverrebbe la sua manifestazione (Omero, Iliade: “Terribili son gli dèi se si manifestano alla luce del giorno”). Infatti il nome è formato dall’aggettivo odhr furioso e Ano avo, antenato, nonno. Odino, divinità scandinava equiparabile a quella sicana di Adrano, veniva appellato Odhr, Furioso.
- AIRYANEM-VAEJO. È il nome dell’ antica patria degli Irani. Viene descritta nell’Avesta, il testo sacro dei Persiani, come un luogo ameno, un paradiso terrestre che il dio malvagio Angra Mainyu seppellì sotto una coltre di ghiaccio, costringendo così i progenitori dei Persiani ad emigrare. Va notato che lo storico greco Erodoto, fra le tribù che Ciro sottomette nei pressi del territorio persiano, nomina quella dei Germani. L’area geografica mediorientale, che vede nel VI sec. a.C. la Persia come epicentro politico e militare, sembra essere stata l’incubatrice di una cultura e una lingua nord europee che sono state in parte indagate nel saggio “Il paganesimo di Gesù”, gratuitamente fruibile nel sito web miti3000.eu. Il nome Veio, apposto all’antica città fondata nel centro italia in un periodo, forse, in cui il popolo che lo abitava non era piu da identificarsi con quegli Etruschi del VI sec. a.C., da noi conosciuti grazie al contributo delle diverse discipline scientifiche e letterarie, potrebbe essere riconducibile alla volontà, da parte del popolo emigrante, di eternizzare una memoria collettiva in cui trovava posto il ricordo di una migrazione polare. Se fosse così, si spiegherebbe l’affinità linguistica, toponomastica e onomastica che intercorre tra gli Etruschi e i popoli del medio oriente, Persiani, Medi, Mitanni, rami dello stesso popolo migrante. Nell’ambito dell’onomastica, nel nome o titolo di Mastarna, successivamente conosciuto col nome di Servio Tullio, si nota una forte assonanza con il nome del re Ittita Labarna e col re mitanno Barattarna.
- AKILLE. (Ad ampliamento di quanto affermato sul glossario pubblicato nel 2016 per le Ed. Simple consultabile gratuitamente). Da quanto riportato da Omero nel libro XVI, 220,245 dell’Iliade, emerge che Akille, assumendo un ruolo sacerdotale, compie un rito in onore di Zeus dodoneo durante il quale formula un voto a favore del fraterno amico Patroclo. Tutti i passaggi che l’eroe effettua durante il rito, esclusivo uso della coppa in cui egli liba a Zeus, la purificazione della stessa attraverso complicate modalità nonostante che si trovasse in una tenda da campo, la posizione assunta durante il rito, riconducono a quanto qui ipotizzato; non ultimo né di poco conto, afferisce alla certezza della sua iniziazione al dio dodoneo, il significato del suo nome. Esso risulta composto dal prefisso sacerdotale Aki* ed Hell*.
Per le parole contrassegnate da * vi rimandiamo al nostro glossario. - AKRAI. È il nome di una città della Sicilia pre greca, sicana, corrispondente secondo l’opinione degli accademici, all’attuale cittadina di Palazzolo Acreide, nella provincia siracusana. Non passa inosservato il possibile accostamento al teonimo Aker, divinità egiziana, personificazione dell’orizzonte, raffigurata attraverso il sole nascente affiancato da due leoni. L’assonanza con il lessema Aker con cui nella lingua tedesca si indica il campo, un terreno fertile, arabile e coltivabile è altrettanto sconcertante e pertinente. In India, con il termine Acharja, ci si riferisce al maestro spirituale, ovvero a colui che ara il campo (lo spirito del discepolo). Metaforicamente il discepolo rappresenta il terreno fertile sul quale il maestro ara, semina i germi della conoscenza per farvi crescere la perfezione.
- ALBA. Non siamo in grado di fornire una etimologia del lessema, ci limiteremo a farlo rientrare in un lessico che accomuna i Celti ai Sicani (vedi articolo “Celti irlandesi e Sicani” ), ricordando ai lettori che Alba è l’antico nome della Scozia; Alba Longa era il nome della città laziale governata da Amulio, nonno materno di Romolo. Quest’ultimo fonderà Roma servendosi di un rito il quale, secondo la descrizione che ne fa Plutarco nella vita di Romolo, ha molto di celtico. Durante la pratica del rito, lo stesso Romolo assume le sembianze di un sacerdote druidico. Albula era altresì il primo nome del fiume Tevere che scorre dentro la città di Roma. Albula è ancora il nome di un fiume che si trova in Svizzera. L’Appennino lucano è formato dai monti Alburni, sul maggiore di essi, il monte Alburno,si recavano i Lucani per pregare la loro divinità. I Romani, nello stesso luogo edificarono il tempio al dio Alburnus. L’alba è il momento in cui il sole sorge, pertanto l’etimo riconduce all’immagine della bionda sabbia del fiume e al colore delle prime luci proiettate dal sole che nasce.
- ALBA LONGA. Nome della città latina il cui re Amulio era il nonno del fondatore di Roma, Romolo. Il toponimo Alba è il medesimo che indicava la Scozia, luogo in cui le albe sono più “lunghe” di quelle mediterranee. Pertanto, è plausibile che il toponimo laziale, sia stato apposto a ricordo della patria d’origine.
- AMBRONI. Plutarco li cita nella vita di Mario come componenti di una tribù tra quelle che formavano il popolo dei Teutoni, sconfitti dal generale romano nel 102 a.C. presso ” aquae sextiae”, nei pressi di Marsiglia. Plinio il vecchio, sostenendo l’antichità degli Ambroni, i quali abitavano il territorio dell’attuale Umbria (vedi voce), afferma che il nome gli venne dato dai Greci in quanto ritenuti sopravvissuti al diluvio. Per quanto altri possano riferire che il nome di questo antidiluviana popolo derivi dal commercio dell’ambra, cosa che non esclude la convivenza con l’ipotesi qui formulata, si opta per il collegamento dell’appellativo alle acque del diluvio, come riferito da Plinio. L’appellativo verrebbe giustificato dal prestigio che ne deriva dalla antichità del popolo. Seguendo l’autorevolezza delle affermazioni di Plutarco circa le radici germaniche di questa tribù, si trova, tra l’altro, una coerenza etimologia nell’attributo apposto alla tribù. Infatti, nella lingua germanica, con il termine brunnen si indicano le acque pure, di fonte o piovane; acque non contaminate. Il grido di guerra urlato da questo popolo che scendeva in battaglia contro i Romani, consistente nel pronunciare il proprio nome, Ambroni, stando al racconto plutarcheo, voleva essere, a nostro avviso, un monito lanciato alle legioni, le quali stavano per scontrarsi con un popolo che non era stato sconfitto neppure dalle acque del diluvio. Il nome della tribù risulta dunque formato dall’accostamento dei lessemi Am sopra e Brunnen sorgente, fonte, pozzo, fontana, acque. Il lessema am, sopra, ha lo scopo di distinguere le acque terrestri da quelle celesti, dalle cateratte del cielo che originano la pioggia.
- AMMON.Rappresentava la divinità suprema nel numeroso pantheon egiziano, paragonabile ad Adrano per i Sicani o Giove per i Romani. Questa divinità veniva appellata dai suoi adoratori, come riferisce Plutarco, il misterioso e infatti, il suo nome, formato dai lessemi am sopra, e mon mente, lascia intendere che la sua comprensione andava al di là, al di sopra della capacità di comprensione umana. La sua sposa era Amonet, cioè colei in cui alberga il puro pensiero, da am sopra, mon mente e net pulito, netto, puro. Amon durante l’XI dinastia (2160 a.C. – 1944 a.C.), come affermato, ascese la gerarchia degli dèi, sostituendo il dio Montu che, probabilmente, stando al significato del suo nome, divenne inaffidabile. Infatti, il nome Montu è formato dai lessemi Mon mente e two (pronuncia tu) due, con riferimento alla doppiezza; Montu rappresentava il dio dalla lingua biforcuta, dalla mente bivalente, inaffidabile.
- AMONET. Vedi la voce Amon.
- AMORE. L’amore è un sentimento così forte che va al di là di qualsiasi umana comprensione, e che a mala pena può essere spiegato dal significato dell’etimo il quale, tradotto verbo pro verbum am-hor equivale a sopra-udito, cioè un sentire non con l’ausilio di umani organi. Il significato qui fornito ha un equivalente nel termine ikhor che era il nome dato al liquido che circolava nelle vene del dio Marte e che fuoriuscì quando venne ferito da Diomede durante una battaglia (Iliade V, 340). Ikhor, ik hör, significa io sento, percepisco ed equivale a quella particolare percezione che hanno le madri quando i propri figli si trovano in uno stato di pericolo, come si evince dalla preoccupazione di Dione nel vedere la propria figlia Afrodite, ferita nella mano da cui scorre l’ikhor.
Letto da destra verso sinistra amor si legge Roma. La scrittura latina, come si evince dalla fibula prenestina, come tutte le altre anelleniche, aveva senso antiorario. - ANAURO. Fiume della tessaglia, attraversando il quale, Giasone avrebbe perso un sandalo. Questo episodio sarebbe stato predetto dall’oracolo a Pelia re di Jolco, che così avrebbe riconosciuto il nipote quando si sarebbe presentato a lui per recriminare il regno sottratto al padre con raggiri. Molti sono i fiumi dell’antichità il cui nome contiene il prefisso an: Aniene nel Lazio; Anapo ancora in Sicilia…
Il nome Anauro è formato da An cielo o avo, antenato, progenitore e ur antico, primordiale. - ANCONA. È il nome di una città italiana sulla costa adriatica. Secondo il canone venne fondata da un gruppo di cittadini Siracusani che fuggivano dal tiranno Dionigi il vecchio nel 387 a.C. In vero, alla luce di una nuova e più attenta ricostruzione dei fatti, si trattava sì di gente proveniente da Siracusa, ma facente parte dei primevi abitanti della città sicana prima che un gruppo di Greci al seguito del fuggiasco Archia, accolto come supplice dai Siracusani, accedesse alle cariche più alte della politica e permettesse al loro duce, nel 734 a.C., di diventare tiranno, istituzione fino ad allora sconosciuta ai prischi siculi. Gli antichi abitanti, appellati dai Greci Kiliroi e Gamoroi (vedi voce), relegati ad una posizione politica di secondo piano, divennero l’opposizione politica e, in seguito a un tentativo andato a vuoto, di cacciare il tiranno da Siracusa nel 405 a.C., molti, fuggendo dalla rappresaglia del tiranno, ripararono nelle città sicule dell’isola; alcuni andarono mercenari in Asia al seguito del capitano siculo Soside, come si evince dalla lettura dell’Anabasi di Senofonte, altri ripararono presso le città amiche dell’Italia. Una delle città, etnicamente imparentata con i prischi abitatori della Sicilia, I Sicani, fu Ancona. Il nome della città ha, infatti, una evidente derivazione sicana, come il prefisso An lascia intendere. Il nome della cittadina adriatica risulta dunque composto dall’unione dei lessemi An che significa Avo, antenato e kuh o kun che significano mucca e mandriano o re nella accezione di mandriano di popoli. Pertanto, Liberamente tradotto, il nome della città evocherebbe L’Avo imperante, il corrispettivo dell’Avo furioso dei sicani siciliani, Adrano (vedi voce).
Il fatto che la città di Ancona dedicasse, fin dal primo momento della sua fondazione, le migliori energie alla navigazione e alle attività portuali, rende plausibile un collegamento tra gli abitanti di Ancona e i Kiliroi di Siracusa i quali erano appunto dei portuali e che derivavano il loro appellativo dalla chiglia della nave, Kiel nella lingua germanica, lingua parlata anche dai Sicani. Ma un popolo affine ai Sicani di Sicilia, appellati Kiliroi a Siracusa, Cilliri nella lingua siciliana, erano gli (k)Illiri. Costoro erano stanziati nella costa prospiciente alla città di Ancona, nella penisola balcanica. Questo popolo praticava la pirateria, e nel 231 a.C. era governato dalla regina Teuta, nome affine a quello del re siciliano che governava nella città stato di Innessa, Teuto. Essendo Teuto un nome di chiara derivazione germanica, ne deriva che molti sono gli indizi che conducono alle radici germaniche dei Sicani, degli Illiri e, dunque, dei fondatori della città di Ancona. - ANFIZIONIA. Per anfizionia si intende una confederazione di città accomunate da un culto esercitato nel santuario edificato in una di esse. La città ospitante il santuario disponeva di fondi comuni da impiegare per lo svolgimento delle cerimonie religiose. In un secondo momento l’anfizionia riguardò, oltre le istanze religiose, quelle politiche e militari. L’anfizionia delfica, per esempio, era composta da dodici popoli, ed aveva il santuario di Apollo come luogo in cui si tenevano le riunioni due volte all’anno. Tutti i membri erano tenuti a partecipare alla difesa e all’amministrazione del santuario. Molto numerosa fu l’anfizionia di Delo voluta dagli Ateniesi nel 478 a.C. a cui parteciparono oltre 150 città. Interpretando Plutarco, nell’opera, che narra la vita di Timoleonte, emerge che una anfizionia doveva sussistere nella città di Adrano, ove sorgeva il tempio della divinità omonima. Il nome della divinità siciliana, Adrano, riconduce altresì al significato dell’etimo qui preso in considerazione, essendo palese un suo riferimento alla protezione del culto esercitato dai prischi Sicani da eventuali contaminazioni straniere. Avo, antenato, nonno nell’antico alto tedesco si traduce con il lessema Ano. Pertanto l’etimo anfizionia risulta formato dall’unione del lessema Ano con quello di ve (pronuncia fe), sacro, che tradotto verbo pro verbum forma l’ “Avo-sacro”.
- ANKH. È un simbolo egiziano interpretato come simbolo della vita. Alcuni studiosi ritengono che sia equiparabile al simbolo della croce, simbolo quest’ultimo antichissimo, ritrovato impresso anche su un pithos del terzo millennio a.C., oggi esposto nel museo della città di Adrano in Sicilia. La cultura antica egiziana, come quella etrusca, era ossessivamente incentrata sul cielo e sulla eternità. Partendo dunque dalla religiosità egizia, risulta plausibile fornire una alternativa interpretativa del simbolismo dell’Ankh, la cui forma richiama la chiave che apre una porta, metaforicamente via d’accesso ad una dimensione altra, il cielo. Il nome che compone l’antichissimo archetipo della chiave che apre la porta d’accesso alla vita eterna, risulta infatti composto dai lessemi An cielo e ki terra. Tuttavia, tenendo conto che il suffisso ki si trova a comporre i nomi dei sacerdoti che operavano alla corte di Davide e successivamente in quella di Salomone: Akitofel (uno dei trenta che componevano la guardia di Davide); Akitob; Achinadab; Achimaas ecc. riconducedo il lessema ki ad una semantica del sacro, si può ritenere che derivi dal lessema acht azione, atto, sacrificio, con riferimento all’azione rituale esplicata dai sacerdoti del culto israeliti. L’atto, l’azione rituale, il sacrificio attuato dal sacerdote col fine di stabilire un contatto con la divinità – questa veniva attratta dall’odore del fumo emesso dal grasso collante sulla pira- veniva assimilato alla chiave che forniva l’accesso alla via del cielo e dell’eternità.
- ANNA PERENNA. È la mitica divinità romana che viene anche identificata con il cibo dell’immortalità, l’equivalente dell’ambrosia dei Greci e della manna degli Ebrei. In realtà il nome si riferisce all’Ava romana per antonomasia, Ana in antico alto tedesco. Con il termine di Tawananna si indicava fra gli Ittiti la regina madre (nel dialetto siciliano nonna si dice nanna). Soltanto lei poteva, presso quell’antico popolo, svolgere funzioni in vece del re suo figlio. Nella lingua tedesca taumeln significa vacillare. Fra gli Ittiti, dunque, con l’aggettivo taumeln si intendeva indicare l’Ava vacillante? Ricordiamo, che l’assiriologo Bedřich Hrozný, aveva intuito che la lingua ittita era affine al greco e al latino, e utilizzò l’antico alto tedesco per tradurre delle tavolette ittite incise con caratteri cuneiformi. I Romani al nome di Anna associarono anche il concetto di cibo, è ciò perché intendevano veicolare un metaforico riferimento al nutrimento dello spirito, evocando attraverso il nome della divinità la memoria degli Avi. Si sa, infatti, l’importanza che i Romani davano al culto degli antenati.
- ANUBI. È una divinità egiziana di solito indicata come colui che sovrintende al mondo dei morti, dunque, al mondo di sotto, secondo la visione greca del culto dei morti, corrispondente all’Ade. Stando, però, all’etimologia dell’appellativo con cui viene indicato, il dio sovraintenderebbe al mondo di sopra o, meglio ancora, egli sarebbe un guardiano della porta, la porta che permette di passare dal mondo di qua a quello di là o, ancor più chiaramente interpretando alla lettera il significato del suo nome, dal mondo di sotto a quello di sopra; dalla terra al cielo. Infatti il suo nome risulta formato dall’accostamento del lessema An, cielo e oben (uban in a.t.a) che significa sopra, superiore. Il fatto, poi, che egli pronunci, attraverso la pesatura del cuore del defunto, il giudizio sulle azioni compiute da chi si presenta alla soglia, come racconta il mito, stabilendo chi sia nelle condizioni adeguate per attraversare la porta, fa di lui un dio preposto alla iniziazione.
- ARA. La radice AR che si ritrova nei nomi, ara, aratro, arena etc. è di difficile interpretazione. Tuttavia è possibile rintracciarvi un riferimento di primordialità collegato alla terra. I Romani solevano sacrificare agli dei a terra. A secondo se il sacrificio era destinato agli dèi del cielo, della terra o degli inferi, formavano nella terra rispettivamente un altaria, sopraelevato, un’ara, alla medesima altezza del suolo, o una fossa.
- ASSUR. È il nome del dio della guerra assiro, nonché il nome della capitale dell’Assiria prima che venisse fondata Ninive. Il nome risulta formato dal lessema Hass che ha un doppio significato: nella lingua tedesca significa odio, ma nel linguaggio delle rune, la runa Hass ha valore di creatività, riferendosi al dio che crea con la parola. La poesia Scaldica amava giocare con le metafore e a uno stesso vocabolo venivano dati significati opposti. Platone, accennando nel Minosse ai due miti contrapposti che volevano il re cretese giudice saggio da un lato e dall’altro odioso ai Greci, conferma il doppio significato del lessema hass che forma il nome Minosse. Il re, venendo appellato Mn+hass rimandava al concetto di dualismo: la mente odiosa e distruttiva opposta alla mente che ama e creatrice. Assur il dio più antico (Ur), potrebbe dunque riferirsi al dio primordiale (Ur) della creazione (hass).
- ATTO. Il termine è traducibile nella lingua tedesca attraverso il lessema Akt. Il termine germanico si è conservato nella lingua latina (acta pilati, acta senatus etc. ), e contiene in nuce un significato afferente alla semantica del sacro: l’atto creativo del mondo da parte di una divinità, che, per gli Ebrei è Jawe’, per gli Indiani Parajati, per i Germani Ymir etc. Nel mito della creazione, che riguarda le religioni sopra citate, l’atto è assimilabile al concetto di sacrificio. Infatti, nel Veda, Parajati smembra se stesso e dai suoi pezzi viene a formarsi l’universo; il gigante Ymir, nel mito scandinavo, viene smembrato dai fratelli divini Vili, Ve e Odino e dai suoi pezzi verrà a formarsi il creato, nei vangeli Yawe’ sacrifica’ il proprio figlio per la salvezza del mondo. Il termine akt, atto, subirà la trasformazione in quello di patto, sinonimo di contratto. Il termine derivato non ha più, perciò, il valore di sacralità, ma mantiene l’impegno a rispettare la parola data, a cui viene demandato il concetto di onore. La inadempienza da parte di uno dei contraenti, comporta una sanzione. I Romani, gli Ittiti, gli Ebrei stipulavano patti sia con le proprie divinità che con quelle che proteggevano i popoli a loro ostili. Un caso emblematico di patto effettuato tra uomini e dèi è quello stretto nel 396 a.C. tra il generale romano Camillo e la dea Giunone, protettrice della città di Veio, che il generale romano assediava invano da decenni (T. Livio, Ab Urbe condita, lib. V,21). Il contratto prevedeva che la dea cessasse di fornire la propria protezione alla città di Veio, dietro un lauto compenso da parte romana. Questa si impegnava di fornire alla dea la decima del bottino e a edificare in suo onore un tempio sull’Aventino. Va notato che il termine pactum subisce ancora una trasformazione diventando pax: infatti, un buon patto tra le parti conduce inevitabilmente ad una duratura pace.
- ATTO CLAUSO. È il nome sabino di Appio Claudio prima che questi si trasferisse nel 504 a. C. dalla città sabina di Irregillo a Roma e diventasse un senatore dell’Urbe. Il nome del nostro Sabino fornisce un indizio per poter affermare che i popoli italici (Rutuli, Sicani, Boi Sabini, Latini), parlassero una lingua simile a quella germanica. È ipotizzabile che l’attributo Akt Glau fosse stato apposto al Nostro per indicare il suo modo di esporre in modo chiaro, senza mezzi termini, la sua posizione politica. Nella lingua tedesca Glau significa infatti limpido, chiaro, perspicace e akt, atto, azione nella accezione di comportamento, modo di agire. È singolarmente curioso che l’augure Atto Navio (vedi voce), definito famoso da T. Livio (Ab Urbe condita lib. I, 36) sia presente a Roma durante il regno di Tarquinio Prisco, perciò contemporaneo e forse parente del Nostro. Infatti, Atto Clauso, non dovette essere meno illustre di Navio se cinque anni dopo la cacciata di Tarquinio il superbo, fu seguito a Roma da cinquemila concittadini, ai quali fece immediatamente riconoscere la tanto ambita cittadinanza romana ed egli stesso venne eletto senatore e, qualche anno dopo, perfino console. Appaiono altrettanto sospette le circostanze del suo passaggio a Roma, quando cioè i Sabini erano spaccati circa la decisione da prendere, se appoggiare i Tarquini che intendevano riprendere il trono di Roma dopo la loro cacciata o dare man forte all’Urbe. È possibile che l’ostilità di Atto Navio manifestata nei confronti del re etrusco, come trapela dalla storia raccontata da T. Livio, venga continuata dal “congiunto” Atto Clauso.
- ATTO NAVO. Era un augure appartenente al popolo dei sabini. Chi ne volesse conoscere le opere, che tanta impressione fecero al superbo re Tarquinio, può consultare T. Livio, Ab Urbe condita, lib. I,36. A noi, in questa sede, preme focalizzare l’attenzione sulla provenienza nord europea dei popoli che abitarono il centro Italia nel momento in cui Roma veniva fondata. Il termine sabino, risulta composto dall’unione dei lessemi sa, dal verbo sehen conoscere, vedere, e ab, da, provenienza, sottrazione. Pertanto, con il nome sabino veniva indicata la persona dalla quale proveniva la conoscenza (veggente, augure). Riteniamo pertanto, che il popolo dei Sabini, fornisse Auguri per interpretare il volere degli dèi a chi ne facesse richiesta, e che l’aruspicina, cioè l’arte divinatoria che consisteva nell’interpretazione del volere divino attraverso il volo degli uccelli, non avesse avuto origini etrusche. Non va altresì trascurato, onde si comprendano le affinità tra i popoli italici e quelli germanici dei primordi, che, secondo il mito scandinavo, Odino si serviva di due corvi per conoscere ciò che accadeva nel mondo. Da quanto emerge dalle affermazioni di T. Livio, Atto Navo si trovava in qualità di aruspice, al servizio di Tarquinio il superbo. Se le opere di Atto Navo confermerebbero da un lato quanto qui esposto, dall’altro anche l’attributo Akt, da cui deriva il nome Atto, indicava in origine il ruolo di sacerdote.
Si aggiunga che un sacerdote, o mago, come venivano definiti in Persia coloro che operavano in quella grigia via di mezzo posta tra il fisico e il metafisico, oppositore delle “azioni” di Zarathustra, chiamato Akt, viene citato nel testo sacro degli Irani, l’Avesta. Il nome Navo ricondurrebbe, se abbiamo colto nel segno facendolo derivare da nau, nave, barca, al simbolismo della nave. Questo simbolismo è stato mutuato, quale attributo apposto al papa, dal cattolicesimo, nell’accezione di nocchiero, il quale dovrebbe guidare la Chiesa Cristiana fra le fragorose onde del grande mare del materialismo. Stando a Plotino secondo cui “Ogni essere è in atto ed è atto – (Enneadi)”, il sacerdote, Akt, avrebbe avuto dunque il compito di traghettare gli uomini dal mondo umano a quello divino grazie ad una serie di “atti” positivi da lui compiuti. Nelle Upanisad il termine atto ricorre con inusitata frequenza per intendere il sacrificio religioso. L’atto per eccellenza, in tutte le religioni, consiste nella creazione del mondo, della vita, dell’uomo da parte di Dio. Il fatto che Navio, sfidato da Tarquinio, riesca a tagliare una pietra con un rasoio, come raccontato da T. Livio, lo pone tuttavia in una posizione che ha più a che fare con i maghi e gli sciamani che con i sacerdoti, per quanto in tempi antichissimi questo confine fosse difficile da stabilire o addirittura inesistente. - AUGURI/E. Con il vocabolo augurium si intendeva esprimere nella lingua latina un presagio favorevole inviato dagli dèi. Il termine risulta composto dal lessema augh, con il quale nella lingua germanica si designava il favore divino, e Ur con il significato di antico, primordiale. Con il termine Augh+ur dovette dunque sottindentersi il primo patto suggellato tra umano e divino. Da allora innanzi, l’augure dovette rappresentare colui che era stato incaricato di verificare che il patto non venisse violato e che gli uomini potessero ancora godere del favore divino.
B
- BATTISTA. Attributo apposto al precursore di Gesù che è diventato in seguito un nome di persona. Deriva da Bad bagno, baden bagnare. Il Battista (bad ist da) era colui che bagnava, che immergeva qualcuno nell’acqua.
- BOLSENA.Volsena era il nome di una città etrusca. Presso questa città veniva esercitato un culto dedicato al dio Fanum. I cittadini delle città etrusche che intendevano partecipare alle assemblee collettive pubbliche, si riunivano presso l’attuale città di Bolsena. Questa prassi democratica, ricorda quella praticata dai Galli, descritta da Cesare nel suo trattato La Guerra Gallica. I Galli, come riferisce il comandante romano, si riunivano presso la città dei Neti, che nella lingua germanica significa i puri, da net. In Irlanda, i Celti si riunivano presso la collina di Tara per eleggere il loro re, e, a tal proposito, si mette in evidenza l’affinità del toponimo irlandese Tara, con il toponimo con cui venne nominata una delle più antiche città etrusche, Tarquinia, Tara-Quelle (tarn nascosto, quelle fonte). Alla luce di quanto affermato, si fa derivare il toponimo Volsena dall’unione del lessema volk popolo con sinn sentimento, senso, conoscenza; oppure dall’unione di Bal Signore e Sinn conoscenza, sentimento. Accettando quest’ultima ipotesi si spiegherebbe il motivo per cui gli Etruschi ritenevano il tempio di Fasnom (Fanum) edificato presso Bolsena, il centro del mondo, l’ombelico di Bal, il signore (?).
- BOLSKAN. È il nome di un paesino della Spagna. I rapporti di affinità etnica tra la Spagna e la Sicilia furono messi già in evidenza da Tucidide nella sua opera La Guerra del Peloponneso. Poiché i Sicani erano stanziali anche nel Lazio, le origini del toponimo spagnolo potrebbero essere comparabili con il toponimo che si trova nell’Italia centrale: Bolsena. Il toponimo spagnolo potrebbe pertanto essere così suddiviso: volk-skan, il popolo degli S(i)Kani. La Skania è il nome di una regione a sud della Svezia da cui, secondo ipotesi alternative fornite da studiosi indipendenti, sarebbero emigrati i Sicani.
- BRAMASTRA. È il nome di un’arma particolarmente letale, capace di scagliare raggi infuocati, come emerge dalla descrizione contenuta nei Veda, di cui si servono gli dèi in guerra tra loro. Il vocabolo risulta formato dal verbo tedesco brennen, che significa bruciare, e strahl, che significa raggio: il nome indica pertanto un’arma letale, capace di lanciare raggi infuocati equiparabili ai raggi laser.
- BRANCO. Nome di persona ancora attuale in alcuni paesi slavi. Era il nome di un figlio del dio Apollo. Branco, divenuto sacerdote del culto paterno, diede origine alla potente casta sacerdotale dei Branchidi che esercitò il culto a Mileto, durante il VI sec. a.C. A Mileto venne edificato ad Apollo un tempio ad di inusitata imponenza e furono erette enormi statue, ancora visitabili, alla illustre famiglia di stirpe divina. Il nome Branco deriva dal verbo brennen incendiare, ardere da cui proviene anche quello del gallo Brenno, l’incendiario che nel 390 a.C. mise a ferro e fuoco Roma. La derivazione nordica del nome del dio della luminosità, viene avvalorata dal mito. Esso, infatti, fa riferimento alla migrazione di Apollo dalla lontana terra degli Iperborei fino alla Grecia. Il dio trascorrerebbe sei mesi in Grecia e sei mesi nella sua patria originaria. Nel mito è evidente l’analogia con l’anno boreale: sei mesi di luce e sei mesi di buio.
- BRENDANO. È il nome di un Monaco irlandese vissuto a cavallo tra il quinto e il sesto secolo.
Il suo nome risulta formato dall’unione dei lessemi brend, che nelle lingue di derivazione germanica significa bruciare, ardere e Ano che in antico alto tedesco significa avo, antenato. Dunque, il nome del Monaco, liberamente tradotto, significa il fuoco degli Avi, colui in cui si manifesta l’ardore che promana dagli antenati.
C
- CAINO. È un personaggio citato nell’Antico Testamento che, secondo la narrazione testamentaria, sarebbe stato il primo fondatore di città. Da Caino, secondo il libro della Genesi, sarebbe venuta l’arte di battere il ferro, ritenuta un’arte sacra. La metallurgia venne ritenuta una pratica iniziatica in quanto si credeva che facesse sprigionare delle forze magiche (il potere della trasformazione?). Il nome Caino deriverebbe pertanto dal germanico Kan potere, nella accezione di creare, e inna dentro (le viscere della terra da cui si estrae il metallo?). In Genesi 4,22, ritroviamo Tubal Cain, progenie di Caino, a capo dei fabbri cainiti, rivestito di grande autorità e appellato “Padre (o signore, da Bal) di quanti lavorano il rame e il ferro”.
- CARMELO. Il monte Carmelo si trova in Galilea dove oggi si esercita un importante culto nei confronti dell’arcangelo Michele . È ritenuto da sempre un monte sacro. Fu visitato anche da Pitagora, mentre Elia sulle sue pendici partecipò ad una disputa con i profeti di Balaam. L’oronimo risulta formato dall’accostamento del nesso consonantico kr, con il significato di forza violenta, che spezza, da cui deriva il vocabolo krptr in a.t.a., che significa appunto rompere, spezzare, al lessema hell cielo, sebbene sarebbe più appropriato tradurlo con spazio. Traducendo dunque verbum pro verbo il nome del monte kr-am-hell si avrebbe: potenza-sopra-cielo. Liberamente tradotto, l’oronimo potrebbe indicare il luogo in cui la potenza prorompe dallo spazio. Il nesso consonantico kr che indica una forza applicata ad un oggetto fino al limite della rottura, forma il lessema Carrè che, oltre ad essere il nome di una cittadina del Veneto, regione notoriamente abitata dai Galli, indica la fortezza, il quadrato, forma dell’accampamento romano.
- CALATINO. Con il toponimo Calatino, si designa ancor oggi un ampio territorio, del quale fanno parte oltre che alla città di Caltagirone quelle di Mineo e Palagonia. Nel 260 a. C., venne apposto come soprannome al console Aulo Atilio durante la prima guerra punica, per onorarlo della vittoria conseguita sui Siculi. Noi siamo propensi ad attribuirne il conio ai Sicani che, come affermato altrove, parlavano una lingua agglutinante, proprio come nel tedesco attuale, riconducibile al proto germanico. Riteniamo pertanto che il toponimo sia formato dall’unione dei lessemi Kalla, acht, inna, che tradotto verbum pro verbo significa chiamare, azione, dentro. La libera traduzione da noi effettuata lascerebbe intendere che il luogo fosse stato scelto come il più idoneo per una chiamata a raccolta del prisco popolo siculo per condurre una azione bellica rivolta contro lo straniero invasore. Si noti che in greco antico καλέω significa chiamare, fare venire, invitare, invocare.
- CALDEI. Nome dei componenti della casta sacerdotale persiana, espertissimi in molte scienze tra le quali la fisiognomica, Plutarco racconta che assieme ad un ambasciatore del gran re di Persia Arsace, inviato a Roma, c’era un Caldeo che, dopo aver scrutato attentamente Silla, che in quel momento rappresentava il Senato Romano, si disse meravigliato che quell’uomo, destinato a diventare grandissimo, sopportasse di non essere già il primo fra gli uomini. Il nome deriva dal verbo Kalla, chiamare, evocare, cantare; indica l’atto del recitare carmi o formule. I Caldei erano dunque gli evocatori, coloro che chiamavano la divinità.
- CAMASTRA (MOTTA).È il nome di un piccolo villaggio della Sicilia orientale. Nel 2020, un gruppo di studiosi vi si è recato per osservare e studiare il fenomeno del solstizio d’inverno che, si presuppone, gli antenati sicani festeggiavano rendendo il culto. L’ipotesi è che il nome del villaggio possa prendere spunto dal ben noto evento che nella cultura indoeuropea ebbe un profondo significato metafisico, mutuato da altre religioni sorte posteriormente, oltre che astronomico collegato alla pratica dell’agricoltura. Infatti il toponimo risulta formato dall’unione dei lessemi cam giungere, venire e strahl raggio, strale. Liberamente tradotto il nome indicherebbe il luogo ove il primo raggio di sole giunge, viene creato, risorge. Per ciò che riguarda l’etimo Motta, che forma il doppio nome del paesino e che venne aggiunto in un secondo tempo al nome originario, esso potrebbe derivare dalla deformazione del verbo Machen fare, nell’accezione di creare. Macht, infatti, nella lingua tedesca significa potenza, forza (creatrice), autorevolezza. Pertanto, il nome completo del paesino siciliano potrebbe riferirsi ad un luogo in cui si origina, si crea il nuovo raggio di luce ovvero la vita o la resurrezione.
- CARRARA. Città italiana famosa per l’estrazione dei pregiati marmi. E da questa caratteristica la città deriva il proprio nome. Infatti, carré significa, pietra, quadrato, fortezza. Nel nome Carrè, è contenuto il nesso consonantico kr, suono onomatopeico che riconduce all’immagine di un oggetto che si spezza. Il nesso consonantico è appunto presente nei lessemi crepa, crack, nel tedesco kraft, nell’antico alto tedesco Kraptr, termini che riconducono al concetto di qualcosa di estremamente duro che si lesiona o si spezza.
- CASA.(Vedi la voce Orus).
- CILLIRI. In greco Kiliroi. Il nome indica la popolazione pre greca che abitava la città di Siracusa ancora al tempo dei Greci. Poiché gli storici facevano cenno anche ai gamoroi, che assieme ai cilliri partecipavano agli scontri politici in corso nella polis siciliana (vedi l’articolo “I cilliri del Simeto” ) durante L’VIII sec. a.C, riteniamo che quello di cilliri sia un attributo apposto ad una consorteria di lavoratori portuali, che furono costretti a intraprendere una serie di lotte sociali. Infatti i Kiliroi erano I costruttori della chiglia, ovvero, per metonimia, delle navi. Si noti che Kiev (chiglia) è il nome di una città portuale dell’Ucraina che è stata edificata sulla riva dell’antico fiume Varustana (vedi voce Dnepr) oggi Dnepr; e ancora, il nome del dio mesopotamico Enki, soprannominato Ea, acqua, fa senza dubbio riferimento a Kiel, cioè alla chiglia; egli sarebbe dunque il primo (EN in lingua norrena) sull’acqua, l’ammiraglio. I cilliri vennero identificati, a motivo delle lotte politiche proletarie a cui prendevano parte in modo animoso, come gli estremisti. Di contro, i gamoroi rappresentavano la parte politica moderata, come si evince dal verbo tedesco gemes misurato.
- COLTIVARE. Il rapporto tra l’uomo e la terra è riscontrabile presso tutte le culture di origine indoeuropea. In India il maestro è chiamato akaria, dal germanico akara, terreno fertile, arabile. Infatti, come l’aratro nel suolo affonda il vomere perché il seme vi penetri e germogli, così, nel concetto espresso dagli indiani con il vocabolo akaria, si rende implicito l’atto della semina del proprio insegnamento nello spirito del discepolo, che il maestro compie affinché si preservi la rigogliosa pianta della tradizione. Talmente stretto è il legame tra l’uomo e il terreno fertile, che per incolto si intende sia il terreno non coltivato che l’uomo poco istruito. Non riusciremmo a cogliere il profondo significato dell’etimo se non lo accostassimo al latino humus, humor cioè umore e umido. Infatti, soltanto il terreno umido, a differenza di quello secco, arso e arido, si presta ad essere coltivato e a dar frutto. Da qui potremmo collegare l’etimo al tedesco kühl fresco e Wara umido, acqua. Per rimanere in ambito metaforico e sfatare la credenza del pragmatismo romano alieno da ogni interiore riflessione, citiamo Varrone (De lingua latina V, 59) che paragona il cielo e la terra all’anima e al corpo. L’anima corrisponde al seme “interrato” nel corpo. Seguendo ancora Varrone, si noterà che egli fa riferimento alla separazione dell’anima dal corpo come il seme dalla terra quando germogliando fuoriusce da essa. Il simbolismo del seme, inteso come continuità, trasmissione della conoscenza, che germoglia, venne preso a prestito da tutte le religioni e i gruppi iniziatici ed esoterici.
D
- DAFNE. È il nome della Ninfa di cui si innamorò il dio Apollo. La Ninfa però, non corrispondeva l’amore del dio, perciò, nel momento in cui il dio la stava per rapire, ella rivolse una preghiera al padre,il fiume Ladon, perché potesse sottrarsi a quella violenza. Il padre, allora, mentre Apollo la teneva ancora stretta tra le braccia, la mutò in un albero. Così la Ninfa si fece beffa del dio. Proprio questo è il significato del suo attributo, potendo tradursi il verbo affen con: prendersi beffa, raggirare. Il prefisso da significa qui nella accezione di immanenza. Dunque, la libera traduzione del nome della, ninfa potrebbe essere qui venne raggirato, da+affen.
- DAGALA. È il nome con cui si designano alcune contrade siciliane. Poiché abbiamo osservato che queste contrade hanno una esposizione a mezzogiorno, dunque sono sempre illuminate dalla luce e colpite dai raggi solari, riteniamo possibile l’accostamento del toponimo alle divinità della luce del mondo celtico, in particolare al dio Dagda. Questa divinità celtica era altresì il compagno della dea Dana (da+Ana) protettrice della terra, della fertilità e dell’abbondanza. In una statuetta, Dagda è rappresentato con in mano un cerchio in cui è inscritta una croce: la croce celtica o carro solare. Egli era dunque innegabilmente un dio della luce. Dagon era una divinità onorata dai Filistei dei quali molto è stato detto nel saggio “Il paganesimo di Gesù” . Il toponimo risulta formato dal lessema da, che in tedesco significa qui, in questo luogo, nella accezione di persistenza e immanenza, dag giorno e alla tutto, ovunque. La libera traduzione di Dagala sarebbe quella di qui è sempre luce.
- DNEPR. È un fiume che attraversando la Bielorussia e l’Ucraina si riversa nel Mar Nero. Quello attuale è un nome recente, ma viene citato dallo storico Erodoto con il primitivo nome di varustana che significa la via che conduce alla dimora degli antenati. Infatti l’etimo risulta formato dal lessema Vara fiume, nella accezione di via di trasporto fluviale, usa dimora e ane Avi. Il fiume navigabile mette in comunicazione il Mar Baltico, luogo di provenienza di coloro che coniarono il nome del fiume, con il Mar Nero. Ancora in epoca vichinga, i vareghi, il cui nome significa coloro che vanno sui fiumi, da Vara fiume e gehen andare, si recavano in Russia e a Costantinopoli seguendo la medesima via fluviale. La stessa Russia, stando alle cronache di Nestore messe per iscritto nel XII secolo, secondo cui le popolazioni della futura Russia avrebbero chiesto ai Vareghi di fornire dei re, avrebbe preso il nome dal colore rosso dei capelli di quei Vichinghi svedesi. Molti fiumi europei sono composti dal sostantivo Ana avo: Adrana (attuale Eder) citato da Tacito; Adrano in Spagna e anticamente anche in Sicilia presso la città omonima; Anapo presso Siracusa; Amenano presso Catania; Aniene nel Lazio. I fiumi, presso i Germani e i Greci, venivano associati alla divinità e presso le loro rive venivano svolti riti votivi, come nel caso dello Spercheo che scorreva nella città dei Mirmidoni di cui parla Omero nell’Iliade.
- DRUIDI. Con questo nome ci si riferisce ad una classe di sacerdoti che esercitavano il culto presso le popolazioni galliche e celtiche. Di loro parla Cesare nel De Bello Gallico e attraverso la descrizione che ne fa, emergono caratteristiche assai interessanti. Cesare afferma che erano in grado di manipolare forze extrafisiche. Forse anche Zarathustra, nell’Avesta, parlando del potere di alcuni maghi a lui ostili e della capacità che essi avevano di manipolare forze non meglio definite che il sacerdote persiano chiama dhruj, intende riferirsi a ciò che poté osservare il generale romano. Il nome druidi potrebbe essere composto dal lessema dhr che significa forza (nel greco antico quercia si diceva δρῦς, drus), potere ed eit chiamare, evocare. Il Druida era dunque colui che sapeva evocare le potenze.
- DUAT. Gli antichi Egiziani indicavano con questo termine l’aldilà. Il nome Duat risulta composto dai lessemi two (pronuncia tu) e akt atto, azione. Pertanto il Duat cui fa riferimento il mito egiziano, indicava le due – two- vie che il defunto avrebbe trovato nell’aldilà e delle quali avrebbe dovuto scegliere di percorrerne una. A scelta sopraggiunta, il defunto, cioè la sua anima, doveva attraversare un fiume utilizzando una imbarcazione trovata appositamente nel luogo e posta sul dorso del serpente Apopi. Il defunti doveva dunque essere in grado di destreggiarsi sulle onde e domare la resistenza apposta dal serpente. Il concetto della dicotomia era diffuso in tutte le civiltà: in Sicilia presso i fiumi in cui questi si biforcavano, veniva praticato il culto ai gemelli Palici figli del dio sicano Adrano (Virgilio, Eneide, lib IX); in Grecia uguale concetto si esprime attraverso il mito, quando il defunto si recava presso i fiumi lete e mnemosine, rispettivamente della dimenticanza e del ricordo.
E
- EDEN. Nel libro della Genesi viene affermato che il primo uomo, Adamo, venne posto in un giardino appellato Eden. Il nome di questo giardino risulta composto dai lessemi Eid, con il significato di giuramento, promessa, patto e En che nella lingua norrena significa uno, primo (ein nella lingua tedesca). Non siamo in grado di comprendere il motivo per cui questo giardino venisse appellato così. La spiegazione che ci diamo deriva dalla lettura del passo biblico laddove si parla di questo giardino. Infatti viene affermato che nell’Eden cresceva il metaforico albero della vita e della conoscenza. Ad Adamo era stato dunque imposto il “primo giuramento” o patto, ovvero l’ Eid+En, che consisteva nell’astenersi del cibarsi del frutto dell’albero della vita e della conoscenza.
- ELFI. Nella tradizione germanica erano piccoli esseri che abitavano i boschi e si rendevano utili agli uomini, con i quali entravano spesso in empatia. Il loro nome significa gli aiutanti, dal verbo helfen aiutare.
- ELLE o Helle. Era la nipote del dio dei venti Eolo. Sua madre era la dea delle nubi Nefele. L’etimologia del nome non è chiara, ma i Germani, prima che l’operazione di sincretismo messa in atto dai missionari cristiani giunti in nord Europa stravolgesse le tradizioni dei popoli che vi abitavano, indicavano con questo nome lo spazio interposto tra cielo e terra. In questo spazio, essi credevano che oltre a prodursi le forze naturali, venti, fulmini e tempeste, albergassero le anime degli antenati in attesa di reincarnarsi, i “gehende” ovvero gli andanti. Di questa credenza era traccia anche presso le tradizioni romane, dal momento che Cicerone vi fa riferimento nel “De Divinatione”.
- ENJALIO. Un dio della guerra nominato nell’Iliade, forse più antico di Ares, Marte per i latini. Il nome risulta composto da EN, uno, primo, jah veloce, sensitivo, percettivo, Hell con cui si indicava lo spazio fra terra e cielo in cui albergavano le forze extrafisiche.
- ENNOSIGEO. Uno dei tanti appellativi del dio dalla capigliatura azzurra, era quello di Ennosigeo (Odissea lib. IX, 320). L’appellativo viene pronunciato dai Ciclopi, figli di Poseidone (vedi voce), nell’Odissea; a Ulisse che chiede magnanimità in nome di Zeus protettore degli ospiti, il ciclope Polifemo ricorda allo straniero che è figlio dell’ennosigeo Poseidone, lasciando intendere che l’attributo Ennosigeo conferisca al dio del mare una posizione di superiorità rispetto a quella in cui si trova il dio dell’Olimpo Zeus. Che la posizione di Poseidone nel pantheon greco sia assai prestigiosa, tanto da lasciar intendere che in un determinato momento fosse stato il dio del mare al vertice del pantheon, si avverte nelle stesse parole adulatorie di Zeus rivolte in un passo dell’Odissea (XIII, 140,145) a Poseidone appellandolo l’antico, come a dire il primo, il più anziano. Ed infatti, nell’attributo Ennosigeo è possibile enucleare il lessema EN il cui significato nella lingua norrena, ma anche in quella greca, è quello di uno, primo. Il secondo lessema che compone l’attributo è quello di SIG con il significato di vittorioso, dal verbo tedesco siegen vincere. Poseidone, per i Ciclopi suoi figli, che così lo appellano, era dunque il vittorioso. I Ciclopi, probabilmente, appellando il padre con l’aggettivo vittorioso, facevano riferimento al mito secondo il quale, nella guerra intercorsa tra le divinità dell’Olimpo per la scalata al trono divino, il dio del mare aveva, in una prima fase, avuta la meglio sul fratello Zeus, relegando questi nel Tartaro.
- ENOTRIA. È il nome arcaico dell’Italia prima che questa venisse chiamata Saturnia e, in ultimo, Italia secondo quanto affermato da Virgilio nell’Eneide. Il toponimo risulta formato dall’accostamento del lessema En, che in antico nordico significa uno, primo e odhr che, stando a quanto afferma Adamo da Brera, significa furioso. L’aggettivo furioso potrebbe riferirsi agli abitatori, gli Enotri appunto, popolo notoriamente combattivo. Gli Enotri, stando al significato dell’appellativo, sarebbero stati definiti i primi o i più furiosi tra gli abitatori della penisola, l’Enotria, che da loro mutuo’ il nome.
- EOLO. Era il dio dei venti. Il suo regno era tradizionalmente collocato nell’isola di Lipari. Tra i tanti figliuoli vi era Nefele dea delle nubi. L’etimologia del nome non è chiara, tuttavia, si potrebbe azzardare che in esso sia racchiuso un riferimento alle acque di mezzo, cioè quelle che stanno tra cielo e terra. Infatti, il suo nome potrebbe essersi formato per unione dei lessemi Ea (Ea era l’appellativo del dio mesopotamico Enki – vedi voce -) acqua ed Elle spazio. A questa conclusione ci fa approdare la constatazione che i nomi apposti ai suoi discendenti si riferiscono alle forze che si producono nell’etere: nuvole (governate dalla figlia Nefele); lo spazio, dalla nipote Elle; I venti e le acque di mezzo, ovvero le acque primordiali, da Eolo in persona. Il riferimento alle acque primordiali che avevano la propria sede nel “firmamento” si trova anche in Genesi 1, 6-10 dove si legge che Dio separò le acque, che in origine si trovavano soltanto nel firmamento, chiamando cielo quelle superiori e mari quelle inferiori. Potremmo azzardare pure l’ipotesi secondo la quale, in chiave metaforica, il precipitare di Elle dal cielo, dove vola sul dorso dell’Ariete del vello d’oro, nel mare che da lei prende il nome, l’Ellesponto, stia a significare la separazione tra le acque di sopra e le acque di sotto di cui si dice nella Genesi. In questo caso ci si ricollegherebbe alla tesi a cui aderiscono molti studiosi, dell’esistenza di un mito originario comune a tutti i popoli.
- ERCOLE. Il nome Ercole, Ercules in Latino e probabilmente Herkohle in protogermanico, (Kohler significa carbonaio nella lingua tedesca) risulta formato dall’unione dei lessemi Her con il significato di signore e kohle con il significato di carbone nella accezione di nero (nero come il carbone).
Nel poema ‘Lo scudo di Eracle’, Esiodo fa cenno a un particolare che a noi non è sfuggito. Il poeta afferma che il semidio viene generato da Alcmena al Cronio della “nuvola nera”. Noi siamo certi che l’appellativo apposto a Zeus per l’occasione, non sia stato casuale, ma esso serviva al poeta, al fine di veicolare una eredità caratteriale appartenuta al padre e passata nel figlio. A indurre i poeti a coniare l’appellativo apposto al figlio di Zeus, comprensibilmente sempre di umore “nero”, non escludiamo che potesse concorrere il suo destino, quello di essere sempre in lite con qualcuno ed, infine, essere sottoposto alle famose dodici fatiche, per poi compiersi il suo ‘nero” destino. Infatti, l’ eroe, secondo la versione del mito più accreditata tra, sarebbe morto per un equivoco indotto dall’eccesso d’amore profuso dalla propria moglie. L’appellativo nero, non era comunque esclusivo della cultura greca, lo ritroviamo apposto a due re norvegesi omonimi vissuti durante il periodo vichingo, gli Halfdanr norreni che erano nonno e nipote. Anche nella mitologia induista il dio Krsna viene appellato il nero, essendo nato da un “capello nero” del dio Shiva. - ETNA/EITHNE. Per l’importanza che attribuiamo al significato dell’etimo, si intende riprendere in questa sede, ampliandolo, quanto affermato a Pag. 77 del glossario pubblicato nel 2016 e gratuitamente fruibile.
Nella mitologia irlandese, la dea Eithne era la madre di Cian e la moglie del dio della luce Lugh. I nomi qui riportati sono familiari in particolar modo ai Siciliani, essendo Ciane il nome del fiume che scorre presso Siracusa. Il nome Etna indica invece il vulcano omonimo ed era il nome della città di cui parla Cicerone nel processo a Verre. Era ancora il nome della Ninfa sposa del dio Adrano e madre dei rinomati gemelli divini, gli dèi Palici. Anche il nome del padre di Eithne, Balor è familiare. Baal significa infatti signore e hör ascolto, era il dio dell’ascolto, che accoglieva di buon grado le preghiere dei sudditi. L’aggettivo Baal va a formare il nome del fiume Belice e quello dei Palici (per la legge di Grimm sulla mutazione consonantica, la B si sarebbe trasformata in P) e ancora quello dei monti Peloritani (vedi voce Baal+hör+eithan a pag. 137 del glossario). Il nome della dea irlandese ricorda il verbo gotico Heitan chiamare, invocare, declamare, come pure riteniamo che lo stesso significato debba attribuirsi alla Etna siciliana, ad Atena e al re mesopotamico Etan, il quale, come si evince dalle tavolette cuneiformi tradotte dagli studiosi, non potendo aver figli, invocava gli dèi perché non interrompessero la sua genealogia . - ETRUSCHI.Popolo che, secondo l’opinione corrente, si era insediato nell’Italia centrale intorno all’età del bronzo. Dagli indizi sparsi nelle leggende di diversi popoli, si evince, tuttavia, che un loro insediamento in Italia fosse già avvenuto fin dalla fine dell’ultima glaciazione, circa ottomila anni avanti l’era volgare. Il nome della loro capitale, Vejo, è infatti straordinariamente affine al paradiso perduto dei Persiani, Vaejo. I Persiani, come viene raccontato nell’Avesta, il libro sacro degli Irani, dovettero abbandonare la capitale in seguito all’opera di distruzione provocata dal dio malefico Angra Mainju. Questi avrebbe provocato una glaciazione rendendo inospitale l’intero paese. L’attributo di Etruschi, apposto a questo popolo da chissà quali osservatori esterni, potrebbe essere la conseguenza dei rituali magico religiosi praticati da questo popolo. Infatti, il nome o attributo risulta composto dall’unione dei lessemi trü e scee. Con il primo lessema, nella lingua tedesca, si indica l’inganno, l’illusione, l’essere fosco, intelligibile; attraverso il lessema scee, si fa riferimento ad un comportamento sinistro, irregolare. Dunque, i Tru-scee o Tusci, altro nome con cui veniva indicato il popolo degli Etruschi, erano coloro dai quali bisognava diffidare, guardarsi.
Volendo offrire una ricostruzione alternativa, fermo restando il significato di sinistro attribuito al lessema scee, si potrebbe ipotizzare che il lessema Tu provenga dal germanico tun. Il verbo tedesco tun indica un modo di agire. Pertanto, traducendo liberamente il nome Tusci, potremmo definire questo popolo come quello che opera, agisce secondo un modo sinistro, sospetto, non consueto. Non si esclude la possibilità che anche il nome del popolo degli Osci si origini dal medesimo attributo. È infatti plausibile che una parte della popolazione etrusca, abbandonato il gruppo, si fosse stabilita nella sponda sinistra (scee) del fiume (Tevere). In questo caso si giustificherebbe anche il prefisso O che potrebbe significare acqua. Infatti, nella lingua francese acqua si scrive eau ma si pronuncia o. Anche il nome del mitico portatore della civiltà al popolo sumero, ha come prefisso O, Oanes. Questo personaggio mitico viveva in acqua e aveva il corpo di pesce dalla vita in giù.
F
- FATO. Era superiore agli stessi dei. Infatti neppure loro potevano modificarlo. Il significato è ciò che è stabilito, ciò che è stato detto, consacrato dal rito, essendo il nome formato dall’unione del lessema Ve (pronuncia fe) sacro, e del lessema akt che significa atto, azione, rito.
- FAUSTO. Faustus in latino. Il nome è formato dall’accostamento del lessema Ve (pronuncia fe) sacro, a quello di usa casa. Il significato è quello di un luogo in cui alberga il consenso divino.
- FAVARA. È il nome di una città siciliana e di molte sorgenti che scorrono in vari luoghi della Sicilia, caratterizzate da particolari condizioni di cui diremo. Il termine è composto dall’unione dei lessemi Ve (che in tedesco si pronuncia fe) e Wara che significa acqua. Per ciò che concerne il termine acqua, va detto che gli antichi utilizzavano termini diversi per indicare l’acqua a secondo che essa fosse stagnante o fluente. Nel primo caso si utilizzava il lessema generico EA, ancora rinvenibile nella lingua francese, Eau (pronuncia o). Il soprannome Ea era stato dato al dio sumero Enki, figlio di Ano, per indicare la sua capacità di navigatore. Con il termine Wara, rinvenibile nel tedesco antico wadar e in quello moderno di wasser, si indicava l’acqua che scorreva, dunque un’acqua che portava dentro di sé caratteristiche di purezza. Con il termine wara si indicavano dunque le acque in movimento dei fiumi, delle fonti e quelle che cadevano dal cielo, le piogge; il dio delle acque presso gli indù era Waruna e uno dei due affluenti del Gange in India si chiama Varanà. Erodoto cita il nome del fiume Warusana (fiume-casa-antenati), l’attuale Depnr, che significa la via che conduce alla casa degli avi. I vichinghi svedesi venivano appellati vareghi cioè, coloro che vanno (gehen) per i fiumi (Wara). Non è, ancora, per una semplice casualità che in Italia vi siano molti fiumi che hanno il nome di Vara, come in Liguria. Nel sud Italia vi sono invece molte fonti che si chiamano favara. È stato notato che le acque denominate Favare, in genere fonti, hanno caratteristiche simili ovunque, e sono acque che nel loro percorso scorrono in parte del loro tragitto nel sottosuolo, per poi venire in superficie e continuare la loro corsa verso i fiumi. Da questa principale caratteristica si può dedurre il motivo per cui davanti al termine Wara è stato introdotto il prefisso sacro Ve. Infatti la caratteristica di cui si è detto, riconduce metaforicamente al concetto religioso del dualismo. Nella città di Adrano, in Sicilia, per esempio, le acque delle Favare scorrono presso l’ara degli dèi Palici, i gemelli figli del nume Adrano. Queste fonti hanno la caratteristica di essere state indicate, come asserisce lo storico locale Salvatore Petronio Russo, in illo tempore, con i nomi di acqua chiara e acqua scura. In altri luoghi la caratteristica delle due fonti, era quella di essere calde e fredde (è il caso dei due laghetti presso il tempio dei Palici a Palagonia).
- FAVIGNANA. A molti nomi o attributi, ai quali si voleva fornire un’aura di sacralità, veniva premesso l’aggettivo Ve che nella lingua tedesca viene pronunciato fe. VE era il nome di uno dei tre fratelli divini della mitologia scandinava. Polibio, nella sua opera Storie, nel lib. III, 60, facendo riferimento all’attuale isola di Favignana afferma: “Annone sbarcato all’isola chiamata sacra, faceva…”. Il nome risulterebbe infatti formato dall’accostamento dei lessemi fe-ignis-ana, ovvero sacro-fuoco-ava, il sacro fuoco degli avi.
- FEBO. È il nome di una divinità greca, identificata successivamente con Apollo. In effetti potrebbe trattarsi di una divinità pre greca, come suggerirebbe il nome barbarico che lo contraddistingueava infatti, il nome è formato dall’accostamento del prefisso sacro Ve, pronunciato nella lingua germanica Fe, con il termine germanico bö con il quale si indica una folata di vento impetuoso. La libera traduzione del nome Febo è quella di vento sacro, che potrebbe riferirsi sia a un individuo in carne e ossa che agiva in modo impetuoso, o alla manifestazione di un fenomeno inintelligibile per l’osservatore. Si potrebbe ancora ipotizzare che il dio dei venti della tradizione ittita, la cui lingua è stata decriptata dallo studioso Höronzi grazie all’apporto dell’antico alto tedesco, possa aver tratto la propria origine dal primo caso sopra citato. Apollo (v. voce) veniva assimilato a Febo, tanto che i Greci nell’evocarlo utilizzavano contemporaneamente i due epiteti. La reinterpretazione avanzata da studiosi di ultima generazione, vorrebbe che l’evocazione della divinità, utilizzando contemporaneamente gli epiteti Febo-Apollo ovvero ve+bo+ab+hel, avrebbe dovuto provocare l’intervento del vento (Bö) sacro (ve), proveniente dallo (ab) spazio (Hel).
- FELICITÀ. Felicitàs in latino, indica uno stato di armonia, di equilibrio interiore in cui versa un individuo. L’aggettivo è composto dal lessema fe sacro e probabilmente da lug luminoso. Nel latino, l’aggettivo luminoso potrebbe aver lasciato il posto a loci, il luogo in cui risiede il sacro e dunque l’armonia mundi. Infatti era inteso, presso i Latini che il possessore della Virtus, meritasse il favore degli dèi (Felix, favorito degli dèi), cioè la bona fortuna o felicità. Ancora per i Latini, valeva la credenza che la buona fortuna, formasse un’aura attorno al suo possessore e che essa si irradiasse a chi gli stesse vicino. Quanto affermato potrebbe quindi giustificare la presenza del vocabolo germanico lug, lux per i Latini.
- FEZIALE. Il Feziale nell’antica Roma, era colui che aveva il compito di recarsi presso la città del nemico a cui dichiarare guerra. Dopo aver gettato l’insegna romana oltre il confine e recitato la formula di rito, il feziale doveva tenere il conto del numero dei giorni trascorsi dal momento in cui era stata dichiarata la guerra. Trascorsi senza risultato i giorni che sarebbero dovuti servire al nemico per riflettere e desistere dal prendere le armi, accettando le proposte romane, il feziale dichiarava la guerra “santa” (Ve). L’etimo risulta formato dall’accostamento del prefisso sacro ve che si pronuncia fe, a zahlen contare, numerare.
- FUOCO. Feur in tedesco, risulta formato dall’accostamento del lessema Ve (pronuncia fe) con il riferimento al sacro e Ur che significa antico, primordiale. Infatti, secondo il mito di Prometeo, il titano avrebbe rubato una scintilla del sacro fuoco dall’Olimpo, per farne dono agli uomini.
G
- GALLI/GALATI. ( Integrazione al glossario pag 86). Eliano, a proposito dei Galati (Sulla natura degli animali XVII-XIX), racconta che “Recitano certe preghiere e compiono certe cerimonie sacre che, talora, hanno il dono di attirare gli uccelli”. I Galli, quando scendevano in battaglia contro il nemico, declamavano enfaticamente il loro peana. Il nome del popolo è dunque un attributo che deriva da tale comportamento. Quello dei Galli era il popolo per antonomasia che elevava i canti di guerra, i Kalla. Il testo in cui vengono raccolti gli inni finnici, si chiama kalevala. La Galizia, regione turca che deve il suo nome all’insediamento dei Galli nel III sec. a. C., mantenne il galato quale lingua germanica fino al IV sec. della nostra era. Lo studioso ceco Hronzny, nel 1915, imbattutosi in alcune tavolette ittite scritte in cuneiformi, fu in grado di tradurle avvalendosi dell’antico alto tedesco (ata).
- GENE. Il lessema gene è riconducibile al verbo gehend, andante. infatti il gene “va”, si trasmette cioè dall’avo all’erede, facendo rivivere in qualche modo l’Avo attraverso il discendente, non solo relativamente alla trasmissione degliaspetti somatici ma anche tramite il passaggio di quelli spirituali, conferendo in tal modo l’immortalità agli antenati. Il legame tra gli Avi e gli eredi trapela dal concetto, espresso da Plutarco nella Vita di Camillo, di moto generazionale contenuto nel vocabolo gentes.
- GENIO. In latino ingenium. Con il termine latino si indicava il possesso di una qualità innata. Tuttavia, si può ritenere che la qualità a cui i Latini si riferiscono, poteva migrare da una generazione all’altra: dall’avo all’erede. La conseguenza che ne deriva, è che il termine latino risulta composto dall’unione dei lessemi germanici inna dentro, e gehen andare. La qualità o talento di un antenato passava, “andava” all’erede attraverso il gene. La gente o stirpe, era pertanto concepita come gli andanti, gehende in tedesco. Il gene o il gehende era il trasmettitore dei caratteri che passavano da padre in figlio.
- GIACIGLIO. Non siamo in grado di fornire una etimologia del vocabolo, tuttavia ci preme soffermarci sul suo significato nella lingua italiana, poiché ci permette di fare un collegamento tra le lingue indoeuropee e quella convenzionalmente definita Ursprache, la lingua primordiale. Sulle origini germaniche della lingua parlata da Gesù, l’aramaico, è stato detto nel saggio “Il paganesimo di Gesù”, gratuitamente fruibile. In questa sede ci preme soffermarci sul nome aramaico apposto all’improvvisato giaciglio su cui si adagio’ il patriarca Giacobbe, “bethel”. Ora, nella lingua tedesca Bett significa letto, mentre con il termine Hell veniva indicato lo spazio che sta tra cielo e terra in cui si muovono, secondo l’antica credenza germanica e latina (Cicerone: De divinazione), forze extrafisiche che potevano essere evocate. Giacobbe ritiene, secondo quanto viene affermato in Genesi, 28,1-22, che quel luogo, prima chiamato Luz e dal patriarca rinominato Bethel, sia un luogo abitato dal divino. Ed infatti Luz dovrebbe corrispondere al vocabolo tedesco Lug, luce (Lug, il dio della luce, nella mitologia irlandese era lo sposo di Eithne).
- GILGAMESH. Nel mito babilonese era il re di Uruk. Il lemma games, nella lingua tedesca significa misurato, moderato. Poiché nel mito mesopotamico si fa riferimento ad un suo compagno d’avventura di nome Enkidu, dalle caratteristiche animalsche, da intendersi, fuor di metafora incolto, selvatico, è probabile che quello del re fosse un appellativo apposto al fine di distinguere il civilizzatore Gilgamesh, dal civilizzato Enkidu. La radice Gi, da cui proviene Gea, o la variante Ki contenuta nei nomi dei due eroi babilonesi qui presi in considerazione, riconduce ad un legame che entrambi avrebbero con la terra. Infatti, nella lingua sumera, terra si diceva appunto ki. Il messaggio criptato nei nomi dei due eroi sumeri, vorrebbe, l’uno affrancarsi e signoreggiarla, l’altro adattarvisi e subirla. A fare propendere per questa interpretazione è la considerazione che presso i Sumeri, i re, e fra i due lo è soltanto Gilgamesh, erano considerati i figli del Cielo. Di conseguenza i lemmi Giebel sommità, cima, e games misurato, che compongono il nome di Gilgamesh, si presterebbero ad essere interpretati secondo il ruolo che Gilgamesh svolge nel mito raccontato: il re figlio del cielo domina sulla terra e ammaestra le creature che abitano in essa.
- GIZA.La piana di Giza deve la sua importanza alla presenza delle piramidi e al fatto di essere stata scelta dagli antichi Egiziani, almeno secondo l’opinione corrente, come luogo ove inumare gli illustri defunti, sebbene non sia stata trovata nessuna mummia all’interno di esse. Infatti, le prestigiose mummie dei faraoni e i loro ricchissimi corredi funebri, sono state trovate all’interno delle tombe per loro edificate nella Valle dei Re.
Il nome della famosa pianura, risulterebbe piuttosto collegato al dio sumero Gishzidda, conosciuto in Egitto con l’epiteto di Thoth, divinità che, tra le altre mansioni svolte, era noto perché deputato ad accogliere nell’aldilà le anime dei defunti. Gishzidda ovvero Thot, era figlio del dio sumero Enki e fratello del temuto dio Marduk, quest’ultimo conosciuto in Egitto come Ra.
Alla luce di inedite interpretazioni del contenuto mitologico riguardo al dio Thoth, si ritiene che la famosa pianura di Giza porti il nome sumero di Thoth in quanto questa, con le dimensioni di un chilometro per due che si conciliano con quelle di un qualsiasi laboratorio realizzato all’aria aperta, potrebbe essere stata scelta dalla divinità sumero egiziana come luogo per l’attività che intendeva svolgere. La funzione di quel luogo, rimasta secretata per millenni, potrebbe essere ora desecretata interpretando il significato etimologico del toponimo medesimo. In questo procedimento di rilettura dei dati a nostra disposizione, risulterà utile ricorrere all’antico alto tedesco, in quanto in quella lingua la s veniva fonetizzata come z (Essen = ezzan). Pertanto, si ritiene plausibile accostare il toponimo Giza al vocabolo tedesco Gießen che significa versare, mescere, infondere. L’accostamento del toponimo egiziano al corrispettivo tedesco – esiste in Germania una città chiamata Gießen-è giustificato altresì dall’appartenenza della lingua germanica alla famiglia indoeuropea. Il nome del dio Thoth, infatti, che è uno degli appellativi del dio sumero Gishzidda, potrebbe derivare dal vocabolo tedesco tote, che significa morto, defunto. Stando al mito sia egiziano che sumero, Thoth o Gishzidda, era in grado di risuscitare i morti. Il dio, dunque, secondo il mito, aveva a che fare con l’anima dell’individuo o con quello che veniva definito il soffio vitale preposto a tener in vita un corpo. Il dio egizio Thot, o Gishzidda in lingua sumera, era in grado di agire perciò sugli elementi vitali ed era in grado di far rientrare in un corpo inerte l’anima che lo aveva “da poco” abbandonato, o interrompere le aritmie del cuore inviando impulsi elettrici, né più né meno di come farebbe un medico dei nostri giorni su un infartuato che giungesse al pronto soccorso. Illuminante è a tal proposito il mito sumerico della discesa di Inanna agli Inferi; in questo caso a riportare in vita la dea, rimasta in coma profondo nei meandri del sottosuolo, sarebbe stato il padre e maestro di Gishzidda, Enki. Supponendo ora che la pianura di Giza con i suoi indecifrabili monumenti dei quali non si può escludere la funzione di accumulatori elettromagnetici, avanzata da studiosi di frontiera, poteva essere il luogo di frequentazione del dio sumero nella fase in cui regnò in Egitto (Gishzidda, per volontà degli dèi riuniti a consiglio, aveva sostituito Marduk nel regno d’Egitto, quando era stato condannato in esilio per unanime giudizio dell’assemblea), sarebbe pertanto plausibile immaginare che il significato del toponimo Giza, possa essere collegabile a quello del vocabolo tedesco Gießen, che, come sopra affermato, significa versare, mescere, infondere, specialmente se si prende in considerazione l’interpretazione fornita dal noto sumerologo Z. Sitchin, secondo cui l’appellativo apposto al primo uomo creato in laboratorio da Enki, il lulu, era quello di colui che era stato mischiato. Pertanto Gishzidda significherebbe colui che mesce, attributo pertinente se apposto ad un frequentatore di alambicchi quale era stato Gizidda, formatosi alla scuola del padre Enki.
H
- HIDRANO. È l’appellativo con il quale si indicava uno dei sacerdoti addetti ai piccoli Misteri Eleusini. Lo Hidrano aveva il compito di purificare il neofita, probabilmente attraverso abluzioni in vasche rituali. Infatti, il termine risulta formato dal lessema Hidros acqua e Ano, avo, antenato. Si fa notare che il nome della divinità sicana della Sicilia pre greca era Adrano. L’etimo Hidrano è palesemente barbarico, non greco.
I
- ISIDE. Divinità egiziana, moglie e sorella di Osiride. Identificata con l’assira Isthar, la nascosta o velata (vedi voce). Nella rappresentazione che ne fa Apuleio, la dea si accompagna a due serpi attorcigliate attorno ad un globo, presubilmente un uovo. Orbene, nella lingua tedesca lucertola si dice Eidechse. Il nome di Iside nella forma coptica è HCE, – Ēse- (Eidechse?) e Ἰσις in quella greca. Il nome Iside risulta composto dall’unione dei lessemi Is che indica la terza persona singolare del pronome personale lei, lui equivalente di es in tedesco, ed Eid che nella lingua tedesca ha il significato di giuramento, vincolo, legame. Nella stessa lingua, ma ormai entrato in disuso, il vocabolo Eidam significa genero, e, come sopra affermato, Eidechse lucertola. Statuine rinvenute in Mesopotamia, che rappresentano la dea madre, hanno una curiosa forma serpentiforme. I Greci la rappresentavano nei loro templi talvolta avvolta o comunque accompagnata da una serpe. I faraoni e le loro consorti sono rappresentate con la testa allungata nella sua parte alta e un copricapo la nasconde. Il copricapo è sormontato dalla testa di una serpe, il cobra. Molti teschi appartenuti a faraoni, maschi e femmine, presentano un cranio allungato (artificialmente o naturalmente è oggetto di discussione da parte di studiosi) di forma serpentiforme. Il nome di Iside in caratteri geroglifici, è caratterizzato della presenza del simbolo della serpe. L’equivalente sumerico di Iside è la dea Innanna, e quello siciliano è Proserpina, anche se il mito di quest’ultima appartiene ad una elaborazione greca di un mito molto più antico di provenienza sicana, di cui però non si riesce a risalire, ma la sua identificazione con la dea sicana Hybla appare assai probabile.
K
- KANAAN. Citata nell’antico Testamento – Numeri, 13,2- come una terra che i transfughi Ebrei, provenienti dall’Egitto, avrebbero dovuto conquistare, era una città appartenente al popolo dei Filistei e si trovava in Palestina. Il nome indicava anche la regione. Il toponimo, tradotto con l’ausilio della lingua nordica, si riferisce ad un luogo abitato da gente potente. Infatti il verbo kann è il presente indicativo del verbo tedesco können, che significa, potere, essere capaci di realizzare qualcosa. Pertanto i Cananei erano indicati come i potenti, coloro che “possono”. Quanto qui affermato, viene avvalorato dalle parole utilizzate dagli esploratori inviati da Mosè nel paese di Canaan, i quali, ritornati riferirono: “Il popolo che abita quel paese è potente”, Numeri 13,28; continuando il resoconto, gli esploratori aggiungono il particolare di aver incontrato “i giganti, i figli di Anak”.
- KARMA. Termine utilizzato nella filosofia indù per indicare il destino, o, per meglio dire, una determinata predisposizione dello spirito. Essendo la lingua sanscrita strettamente imparentata con la lingua germanica, non è difficile scorgere nell’etimo induista l’unione dei lessemi kr e am. Con il nesso consonantico kr si intende esprimere l’atto di potenza prodotto dall’Io – rinvenibile anche nel suono onomatopeico che si produce pronunciandolo – e che si spinge quasi fino al limite di rottura dell’oggetto su cui viene applicato, mentre con la preposizione am, sopra, si esprime l’oggettività, l’indipendenza della forza applicata e tuttavia la volontà da parte dello spirito di voler dominare e indirizzare la libera forza manifestata. Nei nomi – che andrebbero intesi come attributi- apposti a personaggi storici o mitologici le cui gesta si svolsero in aree geografiche distanti tra loro, è possibile rintracciare quanto qui affermato: Kr+eso, Kr+isto, Kr+eusa, ecc. rappresentano alcuni personaggi sopraffatti dagli eventi terreni e, dunque, dalla potenza espressa dal nesso consonantico kr, finendo la loro vita in modo cruento o comunque da vittime. Così non è per Kr+sna, la divinità dei Veda, che “sovrasta” gli eventi umani ai quali partecipa, diversamente degli altri personaggi succitati.
- KHUFU. Kufu o Cheope, è il nome del faraone che sarebbe stato sepolto nella piramide che da lui prende il nome. In realtà, la mummia del faraone non è stata trovata mai all’interno della piramide. Nella lingua tedesca, con il lessema kufe, si indica un tino, una botte, nel dialetto adranita esistono ‘u cufenu un cesto di grandi dimensioni,’a cufena, più grande,’ ‘a cuffa, ancora più grande, e ‘a cufinidda, un piccolo cesto, mentre sull’ albero maestro delle navi a vela c’ era la coffa, quasi un mezzo tino, nella quale stava la vedetta. Se si prendessero in considerazione le tesi di ricercatori indipendenti, tra i quali spicca Robert Bauval, tesi secondo le quali si esclude che le tre piramidi siano state costruite per accogliere le mummie dei faraoni, la possibilità che il nome Khufu apposto alla più grande delle tre piramidi della piana di Giza, indichi un contenitore paragonabile ad una botte o a un tino, sarebbe elevata.
- KLIO. Era per i Greci la musa che sovrintendeva alla poesia epica. Letteralmente l’aggettivo avrebbe il significato di piccola, dal tedesco kline. La metafora a cui il nome fa riferimento, riconduce al granello di senape di evangelica memoria: da ciò che è piccolo proviene il grande; nel caso della Musa l’immortalità dell’eroe, ottenuta tramite la poesia epica.
- KREPA-KRAK. Il nesso consonantico kr contenuto in crepa, ma anche in molti nomi o soprannomi di individui, rappresenta un elemento interpretativo della concezione indoeuropea del mondo, troppo importante per essere da noi passata sotto silenzio. Come si può notare in modo molto evidente nei vocaboli crack e crepa, il suono onomatopeico che si ottiene pronunciando, riconduce all’immagine di qualche cosa che si spezza. Osservando i dettagli della vita dei personaggi nei nomi dei quali è inserito il nesso consonantico Kr, si noterà, in primo luogo che non si tratta di individui comuni ma di re, profeti e divinità ; in secondo luogo che la loro vita venne vissuta fuori dagli schemi comuni, al punto da provocare una ‘rottura’ con le convenzioni in uso nella società del loro tempo. La presenza del nesso consonantico kr in un nome, indica che in colui che lo porta si applica, o è egli ad esternarla, una forza che viene condotta su un oggetto fino al limite di sopportazione, quasi a crearne una lesione ma non la completa soluzione di continuità. La crepa, infatti, indebolisce la parete su cui si crea, e tuttavia, lascia ancora la possibilità di un intervento riparatore. Il re Creso distrusse il proprio regno a causa della propria ingordigia, ma, reso prigioniero dal re di Persia Ciro, divenne il più saggio suo consigliere; Cristo finì sì sulla croce, ma, secondo il credo cristiano riscattò il mondo dal peccato.
L
- LEVANA. Presso i Latini era il nome dell’antica dea preposta ad assistere le partorienti. Il nome riconduce al concetto di portare in vita o alla luce ciò che è celato.
Nel nome di Levana, infatti, si può rintracciare la radice AN. Ana significa ava, antenata, nonna. L’aggettivo leu-lug-luk, con il significato di luce, conferisce dunque all’Ava la doppia veste di custode della vita fisica e di quella metafisica, tanto che il suo nome venne utilizzato da una delle sei logge massoniche che nel corso del XIX secolo erano presenti in Adrano, la città in cui sorgeva il tempio dell’Avo della stirpe dei Sicani. Secondo le indicazioni esoteriche della loggia massonica adranita, la dea Levana era dunque preposta all’iniziazione del neofita che, tramite suo, rinasceva a nuova vita. - LITTORE. Il littore, presso i Romani, era colui che portava il fascio di verghe con l’ascia, simbolo del potere regale. I littori al seguito del re erano dodici. Se si considera che questo numero ritorna con frequenza inusitata nella mitologia dei popoli indoeuropei, non si fatica a credere che per essi fosse di buon auspicio (dodici erano le tavole della legge dei Romani, dodici erano i segni dello zodiaco, dodici le fatiche sostenute da Ercole, dodici i principi Feaci etc.). Riteniamo che il vocabolo sia formato dall’accostamento del lessema licht luce, con quello di tor porta. Il licht+tor era dunque colui che annunciava la luce della quale il re romano era portatore, in tempi in cui si credeva ancora che il re fosse il costruttore del ponte – pontifex- che collegava la terra al cielo. Il littore, se teniamo conto del lessema tor che compone il suo nome, era il custode della porta. Sarà ulteriormente chiarificatore del concetto che gli antichi avevano della porta, e a quali pericoli si veniva esposti non vigilando su di essa, il passo biblico (A.T. Giosuè 20,1) in cui si afferma che colui che si era macchiato di omicidio e chiedeva rifugio in una città, doveva arrestarsi alla porta d’ingresso ed esporre agli anziani quanto era accaduto.
- LUCUMONE. Era il nome etrusco del quinto re di Roma che assunse successivamente il nome di Tarquinio Prisco. Quella del Lucumone, in Etruria, terra di provenienza del re, rappresentava una magistratura attribuita ai maggiorenti. Il termine sarebbe formato da luc o lug luce, e mn mente, liberamente traducibile con colui che ha la mente illuminata, cioè, la conoscenza e la saggezza. Pertanto è plausibile che la carica fosse esercitata in ambito religioso e che non coincidesse con quella di re, altrimenti non si comprenderebbe il passaggio di Tarquinio, che in Etruria doveva essere re, a Roma dove divenne re.
M
- MAGIA. Il termine magia lo si fa derivare dalla parola persiana “mag” da cui magi, nome degli appartenenti alla casta sacerdotale della religione persiana, poi riformata da Zarathustra. I Magi erano esperti in tutte le scienze, tra le quali un ruolo particolarmente importante aveva lo studio dell’astrologia. Infatti, attraverso la consultazione degli astri, secondo il vangelo di Matteo, i Magi avrebbero saputo che si sarebbe verificata la nascita di un re straordinario, successivamente identificato con la persona di Gesù. Al termine mago si è dato sbrigativamente il significato di prete, forse condizionati dal fatto che i Magi fossero l’espressione massima della casta sacerdotale, mentre in realtà, essi dominavano tutte le discipline scientifiche e naturali. Lo storico greco Erodoto, vissuto nel V sec. a.C., nel suo trattato, Storie, fa esplicitamente cenno alla presenza di Germani fra le tribù che costituivano il popolo persiano. Molti dei nomi delle tribù che costituiscono il popolo persiano, sono appellativi derivanti dalla lingua germanica. L’influenza culturale germanica in Persia è ravvisabile dallo studio non solo della mitologia persiana, ma anche dal simbolismo adottato dai Persiani e dalla onomastica, una tra tutte, quella che fa riferimento a Ciro (vedi voce). Dal sostantivo mago, dunque, deriva l’etimo magia. Utilizzando il lessema magia, si intende fare riferimento a una pratica atta a far accadere cose che, allo stato “normale” dei processi naturali, non potrebbero accadere; motivo per cui, in altre culture tali accadimenti vengono definiti miracoli. In realtà, i Magi, da cui sarebbero successivamente derivati gli alchimisti, erano coloro i quali, avendo osservato e studiato le forze nascoste della natura, sarebbero riusciti a controllarle, a dominarle. Pertanto, pur essendo necessario possedere requisiti specifici, l’arte della magia è qualcosa che si apprende. Comunque sia, col termine magia si intendeva indicare allora come oggi, lo svolgimento di opere straordinarie. Il termine proviene dal verbo germanico “mögen desiderare, possedere, entrare a far parte di qualcosa divenendo un tutt’uno con la cosa che si vuole ottenere o su cui si intende agire, un fondersi con essa in modo da diventare qualcosa di nuovo e indistinguibile. Il nome Maddalena cioè Magda, dovette derivare il proprio significato proprio dal verbo mögen o perché si volesse con esso indicare una persona che proveniva dalla cittadina di Magda, in Palestina, o perché fosse la desiderata per la sua avvenenza o, ancora, per l’aura di magia che essa sprigionava. È infatti emblematico che la Maddalena dei vangeli, secondo il racconto dell’evangelista Matteo, fosse considerata posseduta da sette demoni. Dando il significato greco al concetto di demone, la donna dei vangeli, cara a Gesù, corrisponderebbe a quella dei testi apocrifi che la descrivevano sapiente ancor più che i discepoli maschi del Messia.
- MEDIA. È la terra ove era stanziato il popolo dei Medi. Il nome di questa terra è affine al Midgard scandinavo con il quale si designava il centro primordiale, la terra di mezzo. In Irlanda vi è una regione chiamata Med. Il significato del lemma è quello di mezzo, metà, centro, spesso inteso nella accezione religiosa di centro spirituale, di polo o asse equilibratrice.
- MEDITERRANEO . Il nome del mitico mare è formato dall’unione dei lessemi germanici med, che significa medio, a metà fra due estremità, nel mezzo di qualcosa, e tarn che significa nascosto, celato. La traduzione del significato del nome del mare quale mondo di mezzo che cela qualche segreto, qui azzardata, risulta corroborata dal contenuto delle tavolette mesopotamiche. In una delle migliaia di tavolette ritrovate in Mesopotamia, intitolata dagli studiosi La visita di Enki a Nippur. tradotta dal sumerologo S. N. Kramer, si legge che il dio Enki, il creatore del genere umano, avrebbe edificato il proprio magnifico palazzo nell’Abzu. Ci sono motivazioni, emergenti da studi condotti, che l’Abzu si trovasse nel Mar Mediterraneo. Nella tavoletta sumerica di cui si è detto, viene riferito che, mentre le divinità si trovavano a banchettare, il fratello di Enki, Enlil, lodando l’edificio, affermava che nella reggia, si “celavano” molti segreti e che si “nascondeva” un sapere indicibile. Anche nel mito egiziano che riguarda la morte di Osiride, viene affermato che il dio Set, per liberarsi del fratello che regnava sull’Egitto, onde impadronirsi del regno fece deporre il cadavere del faraone in una cassa di legno nascondendola nel Mar Mediterraneo. Per una “strana” coincidenza, anche la maga Circe, proveniente dalla lontana Colchide per sfuggire alle ire del fratello e re, Eta, si recò nel Mediterraneo ove, nel Lazio, presso il monte che da lei prese il nome, edificò il proprio palazzo. Nel Circeo, la maga o genetista, come Enki nell’Abzu, nascondeva i propri segreti. Il Mediterraneo ha rappresentato l’incontro di diverse civiltà, alcune delle quali, come quella egiziana, che in Sicilia portò il culto di Iside, praticato in epoca romana e fino all’avvento della religione cristiana, con la quale si ebbe un abile sincretismo fino a identificare la madre di Horus con la madre di Gesù, nasconde dunque affascinanti misteri hanno posto domande a cui non si è saputo fornire risposte soddisfacenti.
- MENTE. Il lemma deriva dalla radice MN. La declinazione del nesso consonantico mn dà vita ad una serie di lessemi collegati all’attività del cervello: pensare, ricordare, tenere a memoria.
- MESSNER. É un nome di persona. Il suo significato, il misuratore, si dispiega sul piano fisico e quello metafisico. Ahura Mazda (mass), che per i Persiani rappresentava la divinità creatrice del mondo, viene spesso indicato come colui che misura, che valuta l’operato dell’uomo.
- MIN. Erodoto, storico greco del V sec. a.C., riferisce – Storie II, 4- che il primo re umano d’Egitto, – prima di lui evidentemente governavano gli dèi – fu Min. Secondo la cronologia fornita allo storico dai sacerdoti egiziani, emerge che i governanti divini arrivarono in Egitto intorno al dodicimila a. C., – si fa notare di volata, che questa datazione coincide con quella a cui si fa risalire l’inabissamento del mitico continente di Atlantide secondo la versione raccontata da Platone nel Timeo e nel Crizia– I Re divini, secondo quanto riferito dai sacerdoti ad Erodoto, prima di abbandonare l’Egitto per ritornare nelle loro sedi celesti, vivevano insieme agli uomini. L’ultima divinità che avrebbe governato in Egitto sarebbe stata Oro, figlio di Osiride. Le informazioni ottenute da Erodoto riguardo agli dèi che regnarono in Egitto, trovano un parallelismo con le informazioni fornite dai monaci buddisti a due commercianti tedeschi F. Mayer Schroder e O. Maman riguardo alla natura divina degli imperatori celesti o figli del cielo che avrebbero governato in Cina, e di cui si parla in alcuni documenti del 1500 a. C. Tornando in Egitto, Min, grazie alla sua spiccata dote mentale, dovrebbe essere stato scelto dalle divinità celesti per governare il paese in loro vece. Che il lessema min esprima il possesso di una dote mentale notevole, lo si evince ancora dall’attributo apposto alla divinità latina Minerva, corrispettivo della greca Atena, nata dalla testa (mente) di Giove-Zeus.
- MINOSSE. Riprendiamo in questa sede quanto detto a proposito del re di Creta su miti3000.eu, arricchendo l’etimo di nuovi significati. Apollodoro – Biblioteca–afferma che Minosse trovò una forte opposizione a Cnosso quando volle succedere al defunto re Asterio. L’unione di Pasifae con un toro, rappresenta la metafora della trasformazione, a Creta, di un regno in una tirannide. Infatti, nella lingua tedesca toro si dice Stier da cui proviene tiranno, mentre con khu mucca, si indicava il re che regnava con il consenso del popolo, da cui deriva lo svedese konung e il tedesco König (vedi l’articolo, I Siculi e la pietra runica di Adrano, miti3000.eu). Il fatto che il nome Minosse sia composto dai lessemi MN mente e Hass odioso, liberamente traducibile con dalla mente perfida o odiosa, avvalora tale tesi. Poiché esiste una tradizione che dipingeva come odioso il re di Creta, di cui fa menzione Platone nel Minosse, crediamo di aver colto nel segno. Tuttavia bisogna credere che il dispotismo a Cnosso fosse di casa se anche il nome del re Asterio vi fa riferimento, come noi crediamo, essendo il nome composto da Hass odio e Stier toro.
- MISTERO/MISTICISMO. I Greci chiamavano mistes l’iniziato. Il vocabolo si inserisce in una semantica del sacro sia nella lingua tedesca che in quella italiana. In quest’ultima, con il termine messa si indica l’ufficio divino esercitato da un Sacerdote. Nella lingua tedesca, con il verbo transitivo messen, si indica l’azione del misurare, per cui Messer è il misuratore. Nell’ Avesta, il testo sacro dei Persiani, il dio Ahura Mazda veniva appellato anche il misuratore. Il vocabolo Maß nella lingua tedesca significa dunque misura, da cui deriva mäßig misurato, qualità che il Mistes intendeva acquisire attraverso la iniziazione ricevuta da una guida spirituale. I Druidi, nel mondo celtico, come si apprende da Cesare nel suo trattato La guerra gallica, istruivano per un periodo di venti anni i neofiti che si recavano da loro per apprendere le arti e le discipline scientifiche.
- MITANNI. Antico popolo che si trovava tra il regno degli Ittiti e quello degli Assiri. È probabile che l’appellativo di Mitanni come quello di Hurriti, che significa gli antichi, da Ur, antico, primordiale, fosse stato loro apposto dagli Ittiti con i quali condividevano le radici culturali. Infatti, il nome di Mitanni significa coloro con cui si hanno in comune gli antenati, da mit che significa con, assieme, in compagnia di, e ahne antenati, Avi. Tushratta era altresì il nome del primo re mitanno, il quale può essere tradotto con l’ausilio della lingua germanica ed avrebbe il significato di colui in cui risiede il buon consiglio. Infatti il nome è formato dall’accostamento del lessema usa casa, dimora e ratt consiglio (in Germania il ratthaus è il comune o palazzo del consiglio). Poiché lo studioso ceco Hronzny tradusse la lingua ittita con l’ausilio dell’antico alto tedesco, se i Mitanni, come noi crediamo erano consanguinei degli Ittiti, dovevano parlare se non la loro stessa lingua, una lingua affine. Erodoto, secoli dopo l’epoca del regno dei Mitanni, nella vicina area geografica denominata Persia, nel VI sec. a.C., segnalerà la presenza di una tribù di Germani sottomessa da Ciro il grande.
- MONTE DI DIO.Il monte sul quale Mosè udì la parola di Dio si chiamava Oreb e, probabilmente, soltanto dopo l’evento che capitò a Mosè, venne appellato Monte di Dio, in quanto la voce che Mosè udì presentò se stessa come la voce del dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Verosimilmente, quel monte, già prima che vi si recasse Mosè, era definito il luogo dell’ascolto. Questo è ciò che lascia supporre il prefisso or che compone il nome oreb. Infatti ör, nelle lingue germaniche significa orecchio, udito, mentre ab significa tratto e indica luogo di provenienza. Il monte Oreb era dunque indicato come il luogo da cui provenivano le voci (del divino).
- MONTU. Vedi voce Amon.
- MUSA. Le Muse, in numero di nove, erano le figlie di Mnemosine, la memoria. Il nome significa la dimora dell’intelletto, da mn mente e usa dimora.
N
- NEBRODI.È il nome di una catena montuosa che si estende dalle falde dell’Etna fino alle coste tirreniche della Sicilia. Agli studiosi della lingua sicana, sostenitori di una medesima derivazione tra questa e il protogermanico, non poteva passare inosservata l’esistenza in Germania dell’antichissimo villaggio di Nebra. Il villaggio si è reso famoso per il rinvenimento in esso, di manufatti risalenti alla fine del paleolitico e soprattutto per il ritrovamento del famoso disco in metallo dell’età del bronzo antico. Nel disco di bronzo, si rileva la presenza di elementi astronomici in oro, sistemati in modo tale da rappresentare una porzione della mappa stellare. Alcuni studiosi, utilizzando argomenti convincenti, frutto di una ricerca condotta su base interdisciplinare, ipotizzano l’esistenza nel pianeta, di una civiltà preistorica globale che utilizzava una lingua comune. Facendo risalire – questa è l’opinione più accreditata da parte di studiosi di ultima generazione– il conio della toponomastica siciliana a tempi immediatamente successivi alla grande inondazione del 10.500 a.C., periodo questo in cui la diaspora linguistica non era ancora avvenuta tra i popoli, si ritiene che toponimi quali sono quello di Nebra e Nebrodi, pur trovandosi in aree geografiche distanti tra loro – in Germania la prima, in Sicilia la seconda. – siano stati apposti a luoghi che manifestavano caratteristiche simili. Utilizzando la lingua germanica come lingua di riferimento per interpretare i toponimi, lingua questa ritenuta affine alla lingua sicana e che trova in quella tedesca una maggiore aderenza, si ipotizza che il toponimo Nebrodi sia formato dall’unione dei lessemi neben, con il significato di vicino, prossimo e Brücke ponte, nella accezione di passaggio, superamento. Si ritiene altresì plausibile, in virtù delle molte relazioni mitologiche, toponomastica e e linguistiche osservate tra la Mesopotamia e la Sicania, che il concetto di passaggio o superamento, possa riferirsi al pianeta di Nibiru citato nel testo sumerico Enuma Elish; questo testo tratta infatti di cosmogonia e pone questo pianeta al centro della trattazione. Il misterioso pianeta di Nibiru veniva appellato dai Sumeri pianeta dell’incrocio, e per questo motivo veniva rappresentato con una croce simile a quella utilizzata dai Templari come loro emblema. Questo tipo di croce è stata rinvenuta presso la città di Adrano, dipinta su corredi rituali di ceramica datati al IV mill. a. C. Per quanto riguarda il famoso disco metallico dell’età del bronzo, detto disco di Nebra dal luogo del ritrovamento, che raffigura elementi astronomici, va osservato che il luogo del suo rinvenimento si trova sulla cima del Mittelber, una collinetta di 252 metri di altezza che gli studiosi hanno interpretata come un osservatorio astronomico del periodo neolitico. A sua volta, la cittadina di Nebra si trova nelle vicinanze dell’osservatorio solare di Goseck, risalente al V millennio a.C.
I Monti Nebrodi vengono anche appellati Monti Caronie. Nella costa tirrenica, presso l’estremità occidentale di questa catena montuosa, si trova il villaggio di Caronia, la famosa Kale Akte fondata nel V sec. a.C. dal condottiero siculo Ducezio. Presso il villaggio di Caronia e dentro di esso, si registrano inspiegabili fenomeni tuttora posti sotto l’osservazione di eminenti studiosi. Non si esclude che tra le cause di questi fenomeni, tra i quali si registrano incendi spontanei di abitazioni e di oggetti vari, possa rientrare il movimento della placca tettonica africana. Questa, presso Caronia, spingendo contro la placca euroasiatica, provocherebbe il punto di “rottura” (broken nella lingua tedesca). Alla luce di questa ultima ipotesi è maturata la possibilità di fare derivare il toponimo siciliano dall’unione del lessema neben, che nella lingua tedesca significa vicino, prossimo, con il lessema broken che significa rompere, spezzare. In questo caso, dunque, il significato del toponimo siciliano apparirebbe pertinente rispetto al fenomeno geologico registrato e alla teoria delle placche tettoniche. Infatti, sebbene non siano ancora molto chiari i meccanismi di questa teoria, in Sicilia, – l’isola fa parte della placca tettonica africana- sarebbero state individuate delle faglie, causate dalla spinta che la placca tettonica africana esercita su quella euroasiatica, creando di conseguenza un punto di rottura. Quanto qui esposto circa l’etimologia del toponimo Nebrodi, accostato allo studio dei movimenti delle placche tettoniche, che porterebbe alla libera interpretazione di vicino o prossimo alla rottura, induce ad ipotizzare che la antichissima civiltà sicana, ritenuta autoctona dallo storico greco del V sec. a.C. Tucidide, fosse così avanzata da possedere conoscenze scientifiche insospettabili, ed essere in grado di coniare, sulla base di queste conoscenze, anche dei toponimi che le richiamino. In questa direzione si sono spinte le indagini di alcuni studiosi di frontiera, i quali hanno trovato incontestabile relazioni tra la cultura sumera e quella sicana. - NEFERTITE. Regina dell’Egitto, moglie del faraone Akenaton. La radice nef va a formare i nomi di molti faraoni egiziani: Neferule, figlia della regina Acesut, Neferote etc. Il fatto che la genealogia della regina Nefertite sia incerta, ha reso possibile ipotizzare che il nome derivi dal vocabolo neffe, che nella lingua tedesca significa nipote, e che venisse applicato al faraone salito al trono quando questi non fosse il figlio/a, ma quello/a del fratello del faraone in carica. La sorella della dea Iside si chiamava Nefti. Iside viene raffigurata spesso assieme a Nefti. Ora, poiché Iside aveva sposato il fratello Osiride, Nefti le era nello stesso tempo sorella, cognata e nipote. Non si può quindi escludere l’ipotesi che, essendo Nefti giovanissima, l’attributo con cui veniva appellata fosse quello di nipote (di Iside). Ancora, se in effetti la cultura dominante fosse stata quella di derivazione germanica, si potrebbe spiegare l’importanza del ruolo del nipote nella cultura egizia. Infatti, presso i popoli germanici I nipoti erano tenuti in così alta considerazione da essere richiesti come ostaggi dai vincitori in luogo dei figli dei maggiori enti. Virgilio, pertanto, da ottimo conoscitore della cultura dei popoli germanici che popolavano il Lazio nel II millennio a.C., Boi, Sicani, Rutuli, Latini etc., nel suo poema l’Eneide, coerentemente con tale cultura, descrive il dolore e la disperazione della moglie del re Latino, Amata, al punto che essa ricorre al suicidio dopo aver appreso la morte del nipote Turno.
- NINFA. Il nome indica delle divinità minori del pantheon greco. In Italia vi è una città nella provincia di Latina con questo nome, dovuto alla presenza di un tempietto romano ad esse dedicato. Il nome potrebbe essere stato formato dall’accostamento del lessema nun che significa ora, adesso (nun nel greco antico) , nella accezione di una presenza non immanente ma eccezionale, casuale, fortuita, occasionale, e Ve che è un prefisso sacro e viene pronunciato Fe in tedesco.
- NINNA NANNA. Con questa cantilena si invitava il neonato ad “entrare” nel mondo “dei nonni”, dal quale proveniva. Inna Ana è infatti traducibile in a.a.t. letteralmente con “dentro” – così da indicare una fase di compenetrazione del neonato nel mondo ultra fisico – e “Antenato”. Non è un caso se tra i Sumeri ritroviamo la dea Innanna, garante tra l’altro della fecondità e considerata, come il suo nome stesso indica, la custode dei valori ancestrali degli Avi, come la latina Vesta, detentrice del sacro fuoco che alimenta la stirpe, la “gens”, gli Avi. La ninna nanna, nel greco antico νάνι νάνι (nani nani), e nel rumeno Nani Nani, aveva dunque alle origini lo scopo di indirizzare e condurre a buon fine il viaggio onirico del neonato, di farlo entrare in contatto con quel mondo, evocando l’Ano.
- NONNO. NONNO, AVO, ANTENATO. Il lessema nonno viene reso nella lingua alto antico tedesca attraverso il sostantivo Ano. Nella lingua siciliana il lessema corrispondente è quello di nannu. Tale sostantivo potrebbe essere formato dall’unione dell’avverbio nah, che nella lingua tedesca significa vicino, accanto, con il sostantivo ano, nonno. Si ritiene pertanto che, nella lingua sicana, col nome composto nannu, si intendesse fare riferimento alla protezione che l’antenato, il nonno, fornisse all’erede, al nipote, con lo stargli accanto, vigilando affinché nulla di male accadesse. La lettura del significato etimologico fornito, verrebbe corroborata dalla constatazione che nella cultura indoeuropea veniva attribuito un rapporto preferenziale tra il nonno e il nipote. Il nah+anu, il nonno, nannu nella “lingua” siciliana, rappresenta, dunque, nella concezione attuale come in quella tradizionale, il protettore, il vigilante, l’angelo custode che sta accanto al nipote, pronto a intervenire in suo aiuto durante i momenti critici.
- NOTO. È il nome di una antichissima città siciliana. Diodoro siculo afferma che la patria del grande condottiero siculo Ducezio era Noa, che è stata identificata con Noto, seppur il condottiero mostrasse uno strettissimo legame con la città dell’attuale Palagonia nei cui pressi sorgeva il celebre tempio degli dèi Palici figli di Adrano ed Etna, di cui Ducezio era, con molta probabilità, sacerdote (vedi “Gli dèi Palici e le sacre sponde del Simeto). Nella mitologia nordica viene indicata la città di Noatun, collocata in Svezia, dove abitano alcune divinità. Nei nostri studi, è stata rilevata una notevole affinità linguistica, mitologica e simbolica tra la Svezia e la Sicilia. Il toponimo scandinavo Noatun significa città delle navi e riteniamo che lo stesso significato abbia quello siciliano Noto/Noa. La città di Noto si trova infatti sulla costa.
- NUMEN. Il numen, per i Romani, rappresentava una generica e indefinibile forza che spingeva l’individuo all’azione. Pertanto, ogni passione, per esempio quella dell’amore piuttosto che dell’odio, veniva gestita dal numen, che poteva essere evocato o manifestarsi autonomamente. Il vocabolo sembra formato dal lessema germanico nun che significa ora, adesso, nella accezione di un apparire, e men mente. Il significato intrinseco al vocabolo è quello di poter spiegare quel corto circuito che si provocava nella mente la quale, contemporaneamente, coltivando la passione, creava dentro di sé una forza e una debolezza. Il contrasto tra queste componenti, era il risultato di qualcosa che si attribuiva ad un agente esterno.
O
- OCEANO. Il lettore avrà certamente riscontrato come spesso nell’onomastica si faccia esplicitamente riferimento, con orgoglio, alle proprie radici etniche. Ebbene, il nome Oceano non fa certo eccezione. Nel mito greco, Oceano era figlio di Urano.
Ora, al ricercatore non sarà passato inosservato che entrambe i nomi sono formati con la radice An. Il sostantivo Ano, nella lingua antico alto germanico significa avo, antenato, nonno, ma anche cielo, sede degli antenati. Pertanto, se si scompone il nome della divinità marina secondo la lingua agglutinante tedesca, utilizzando la grammatica avremo la sequenza: ö-cened-ano. Chi ci ha seguito nelle ricerche dei significati etimologici attribuiti all’onomastica, ricorderà che Oannes era l’appellativo apposto dai Babilonesi agli uomini pesce, esseri questi, secondo il resoconto del sacerdote babilonese Berosso vissuto nel III sec. a. C., civilizzatori venuti dal mare occidentale. Gli Oannes venivano raffigurati nei bassorilievi mesopotamici come esseri per metà pesce e per l’altra metà del corpo uomini. Nella lingua sumera e babilonese acqua si scriveva ea; ignoriamo la fonetizzazione della sillaba, se non che si constata che nell’attuale lingua francese acqua si scrive eau e si pronuncia O. Non appare pertanto peregrina la tesi secondo la quale il prefisso O del nome Oannes indichi proprio l’elemento acqua. Per quanto riguarda il concetto di stirpe veicolato dal nome Oceano, si riscontra che in antico irlandese, il termine cenedl indica un gruppo umano accomunato da vincoli parentali. Del significato di ano si è già detto e dunque non ci ripeteremo. A questo punto si può azzardare una libera interpretazione del nome Oceano: scomposto in o-cenedl-ano, potremmo dedurre che esso fosse un appellativo per indicare una “stirpe di esseri acquatici” che, padroni dell’elemento acqua, si muovevano con grande padronanza in esso. Questa stirpe – cenedl- si riconosceva forse nel comune antenato – ano- il quale potrebbe corrispondere alla figura del dio mesopotamico Enki appellato Ea, cioè acqua. A corroborare questa intuizione afferisce la presenza di alcuni bassorilievi sumerici di tre o quattromila anni fa, in cui vengono rappresentati uomini che con l’ausilio di respiratori dalla forma di otri, esplorano i fondali marini. Ritorna utile alla nostra ricerca, constatare che filosofi dello spessore di Platone si siano interessati al mito del continente Atlantideo, sprofondato nell’Oceano. - OANES. Era considerato dai Babilonesi uno dei sette saggi. Secondo il mito raccontato dal sacerdote Berosso nel suo “Storia di Babilonia”, Oanes sarebbe stato colui che avrebbe portato la civiltà ai Babilonesi. La sua forma era mezza umana e mezza di pesce, a significare forse la sua capacità di dominare i mari. Oane (Oanes sarebbe la forma plurale) for di metafora, sarebbe stato un navigatore, al pari di Jano per i Romani, di Aztacoalt per gli Atzechi, tutti portatori di civiltà. Il nome, infatti, né indicherebbe tali caratteristiche essendo formato dall’unione del lessema Eau o Ea ( forse pronunciato O, come nella lingua francese) che in sumerico significava acqua (il dio sumerico Enki era infatti appellato Ea, acqua, e ach’egli era giunto dal mare), e Anes plurale di Ano avo, antenato. La leggenda babilonese segnala la presenza di più uomini pesce, Oanes. A Lepenski Vir, un antico villaggio del neolitico sul Danubio, in Serbia, sono state ritrovate molte statuine che rappresentano uomini pesce.
- ORACOLO. Il nome è formato dall’unione dei lessemi hör, ascolto e Kalla chiamare, evocare, calare nella accezione di fare discendere il divino. Con il termine oracolo dunque, si intendeva la capacità da parte del sacerdote, di saper ascoltare la voce del divino.
- ORAZIO. Quello di Orazio era un nome frequente nella società latina ed esso appare fin dal primo momento della fondazione di Roma, anzi è strettamente collegato ad essa al punto da far nascere un collegamento tra il nome della famiglia vittoriosa cui appartenne e la stessa sopravvivenza di Roma minacciata dagli Etruschi. Il nome risulta composto dall’unione del lessema hör con il significato di ascolto, ma si tratterebbe di un ascolto non dovuto a percezione sensoriale il cui organo recettore è l’orecchio materiale (or in tedesco), bensì di un ascolto del cuore o orecchio interiore, che si rifà a forme extrasensoriali di percezione, con il lessema akt che significa atto, azione. Dunque Orazio è colui che viene chiamato a compiere un atto sacro, sia pure nella forma di una apparente semplice orazione. Diciamo apparente poiché in chiave magico religiosa la parola rappresenta un atto di creazione. Non per nulla il vangelo di Giovanni inizia affermando che in origine vi era il “Verbo”.
- ORFEO. È il nome di un personaggio mitologico greco. Il nome risulta composto dal lessema hör con il significato di ascolto e dall’aggettivo Ve che in tedesco si pronuncia fe e significa sacro. Infatti Orfeo era un abile suonatore di lira con cui riusciva a incantate uomini e dei. In una rilettura laica del mito, Orfeo avrebbe il ruolo di uno sciamano capace di intraprendere viaggi estatici oltre la dimensione umana. Nel mito avrebbe compiuto un viaggio nell’aldilà per recuperare la defunta e tanto amata moglie Euridice. Orfeo significherebbe dunque, dal sacro ascolto.
- ORGIA. Si fa derivare la voce orgia dal greco orghe’ che significa impeto, forse perché durante i riti dedicati a Bacco, il dio dell’ebrezza, si manifestava nei baccanti un incontrollato furore. A noi pare che il termine sia composto dal lessema hör che significa ascolto, nella sua accezione metafisica, e gehen andare, nel senso di abbandono, di un lasciarsi andare. Con il termine orgia dunque, dovette intendersi quell’atteggiamento sciamanico di una sacra frenesia, grazie alla quale ci si lasciava andare privi di controllo razionale; ci si lasciava rapire da forze primordiali per ritornare al caos indistinto, in cui tutto era confuso o, per meglio dire, fuso, unito, promiscuo.
- OSCI. Vedi la voce Etruschi.
- (h)ORUS. È il nome di una divinità egiziana. Formato dai lessemi hör udito e usa casa, che liberamente tradotto significa la casa dell’ascolto. È il caso di intrattenersi sul termine usa, casa, che designa il luogo stabile di una qualche percezione umana, ma anche sovrumana. In una commedia Plauto fa pronunciare una frase al padrone di casa, molto inerente al concetto che intendiamo chiarire. Rivolto al servo, Simone dice: “Fa in modo, Pseudolo, che la casa delle tue orecchie sia vuota e ascolta bene ciò che ti dico.
- ORVIETO. Il nome dell’antica città etrusca, sembra formato dall’unione dei lessemi Ör ascolto, con il prefisso sacro Ve. Pertanto il nome si riferiva ad un luogo in cui la voce del divino veniva udita da uomini dediti alla ricerca del sacro.
P
- PELASGO. I Pelasgi erano un antichissimo popolo. Vengono collocati dagli storici antichi in ogni luogo del Mediterraneo. Secondo Tucidide furono gli antichi abitatori di Atene. Alcune isole del Mar Mediterraneo appartenenti alla Sicilia portano il loro nome. Riteniamo che il nome sia formato dall’unione dei lessemi Bel signori, hass il nome della runa che indica la potenza della parola creatrice e gonne che significa protezione. Pertanto il Pelasgi era il Signore capace di proteggere con la forza della parola.
- PELORO. Con il nome di Capo Peloro si indica la punta estrema nord orientale della Sicilia, nel territorio di Messina. Qui si trova anche la catena montuosa dei Peloritani. Dione Cassio – Storia Romana, lib. XXXVII, 2- cita con questo nome un fiume che scorreva nei pressi del Bosforo. Nella legge di Grimm, in cui si fa riferimento alla legge della mutazione consonantica, si evince che la B sarebbe mutata in P. Dalla legge di Grim si ricava che la radice bel fa riferimento al Signore, (Bal) e alla possibilità che in questi alti monti della Sicilia orientale, l’ascolto (Ör) cioè la comunicazione tra l’orante e il Signore, sia facilitata dalle condizioni ambientali (vedi voce Peloritani). In Irlanda aveva particolare rinomanza la figura mitologica del re Balor (il Signore che sapeva ascoltare), padre della principessa Eithne. Si noti che i nomi di Balor, corrispondente in Sicilia al nome di Palici, Peloro, Belice etc. ed Etna o Eithne, sono presenti nell’isola con una frequenza inusitata, al punto che è stata avanzata l’ipotesi di una stretta parentela intercorsa tra Sicani e Celti, ipotesi che si basa anche sulla comunanza della lingua, della simbologia e della mitologia.
- PIRAMIDE. Il nome che indica queste imponenti strutture di pietra, contiene il lessema pyr che significa fuoco nella lingua greca, lingua di cui si servì lo storico greco Erodoto, vissuto nel V sec. a. C., per descrivere gli usi e i costumi della terra dei faraoni, terra che in parte egli visitò personalmente. Le tre piramidi contigue della pianura di Giza: Cheope, Kefren e Micerino, erano rivestite di una pietra detta di Tura la quale, colpita dal sole, ne riflettava la luce e il calore, effetto questo, che le consentiva di essere visibile da grandi distanze, forse anche dalla luna. Di conseguenza, la piramide così rivestita, doveva apparire all’osservatore come un grande, indistinto punto di luce, di calore e di fuoco. È plausibile che proprio da questo effetto ottico e termici essa derivasse il proprio nome. L’origine germanica del termine piramide e dunque quello di fuoco, è a nostro avviso deducibile, sintetizzando, dalla parola tedesca feur, fuoco. Poiche il lessema Ve si pronuncia in tedesco fe, e rappresenta un prefisso sacro anteposto al nome, il termine fuoco , feur, era composto dall’accostamento dei lessemi Ve e Ur. Il triangolo, cioè la piramide, segno di UR, del fuoco iniziatico, è entrato altresì a fare successivamente parte del simbolismo alchemico. Per gli individui che si muovevano tra gli alambicchi riscaldati dal perenne fuoco dei loro laboratori segreti, che si vantavano di aver appreso all’ombra dei papiri la loro segreta scienza, direttamente da Ermete Trismegisto, il triangolo isoscele con la punta rivolta in alto indicava il fuoco, mentre quello equilatero indicava la terra. Anche l’iconografia cristiana utilizzò tale simbolismo, basti fare riferimento al cuore di Gesù rappresentato nei dipinti, sormontato da una fiamma e da un triangolo con al vertice la croce. Il termine germanico feur, fuoco, tradotto verbum pro verbo, fornisce la seguente sequenza: sacro e primevo. Come sopra affermato il lessema ve, in tedesco si pronuncia fe da cui deriva il francese feu, fuoco. Nella lingua latina il nesso consonantico PH si pronuncia F. Per ciò che concerne la derivazione germanica della lingua latina, si è detto sufficientemente in molte altre occasioni per ripetersi in questa. Il lessema germanico feur, viene dunque trascritto pheur dai Latini e da loro pronunciato feur. Tuttavia, come si sia giunti al passaggio del lessema pheur di origine germanica alla trascrizione del vocabolo latino ignis per indicare il fuoco, sarebbe interessante indagare, ma non in questa sede. Infatti, in questo caso l’argomento dovrebbe scorrere carsicamente le perigliose vie dello spirito, nelle quali il movimento del feur germanico che brucia e dissolve, giunge ad essere fissato nell’ignis che, invece, immobile, nella profonda sede del cuore, riscalda e tempera (lo spirito). Un passaggio fonetico simile a quello che abbiamo indicato nella lingua latina dovette realizzarsi fra gli indoeuropei Micenei e i propri discendenti, i Greci, per giungere al lessema pyr. Tuttavia, siamo convinti che l’accorto lettore avrà certamente preso coscienza di una inevitabile forzatura che si sosterrebbe facendo derivare il vocabolo germanico veur/feur in quello greco di pyr e, dunque della improbabile trasformazione della F in P, sebbene la legge di Grimm potrebbe essere estesa, ma se si tiene conto del lunghissimo periodo trascorso tra la costruzione delle piramidi, il duemila e cinquecento a.C. per gli accademici ortodossi, il dodicimila a.C. per gli “eretici”, si può comprendere che nessun serio linguista al mondo potrebbe arrogarsi la certezza di aver potuto seguire le modalità della trasmutazione sillabica con cui una lingua inevitabilmente si modifica nel tempo. Sarebbe tedioso elencare i disaccordi in cui incorrono i linguisti, presi da diatribe interne, circa la pronuncia e il significato di alcuni vocaboli. Utile ci sembra invece, ricordare al lettore, che le lingue scritte, definite barbariche dai Greci, non possedevano le vocali e che in origine venivano omesse anche nella scrittura greca. Pertanto pyr veniva trascritto attraverso il nesso consonantico PR.
Dal nostro punto di vista crediamo possibile di poter correggere le falle in cui si può incorrere utilizzando una singola disciplina scientifica, avvalendoci della multidisciplinarietà.
Se, dunque, il primo conio del nome della struttura di pietra deve attribuirsi agli indoeuropei provenienti dal nord Europa in terra d’Egitto, che fuggivano il rigido clima polare, il termine piramide si sarebbe formato da una derivazione germanica della parola fuoco nell’accezione di energia, in quanto il calore è generato dal movimento. Pertanto la modificazione di veur/feur in pheur – pyr, porterebbe alla sequenza dei lessemi germanici; pyr-am-eid, ovvero fuoco (energia) -sopra-legame. Si deve dunque ritenere plausibile che la piramide, in qualche modo, fosse stata concepita per mantenere un legame tra il Cielo, sede degli dèi e Terra, sede degli uomini, in una accezione di vincolo sacro (Ve) tra due dimensioni diverse eppur contigue. Il faraone, a propria volta, assumeva il ruolo di trait d’union (Tutankamon, vedi voce) tra queste due dimensioni. - PLUTONE. Era il re che sovrintendeva al regno dei morti. Nella città di Jerapolis, in Anatolia, gli veniva tributato un culto ctonio, probabilmente presso una grotta che sarebbe stata identificata dagli studiosi. Il nome del dio sarebbe formato dall’unione dei lessemi Blut sangue e one, privo, mancanza, assenza. Richiamando la legge di Grimm e della mutazione consonantica per cui la P è intercambiabile con la B, Blutone governerebbe su quelli che sono privi di sangue, i morti.
- POSEIDONE. Poseidone è il nome greco della divinità che presiede al controllo del mare. Il dio ha molti soprannomi: lo scuotitore della terra; il dio dalla capigliatura azzurra, ennosigeo (vedi voce) ed altri ancora. Nel destino del dio, che teneva moltissimo alla sacralità della parola data e ai giuramenti, vi era quello di incontrare puntualmente individui che, all’opposto, consideravano la parola data una semplice emissione d’aria attraverso la faringe. Uno dei celebri mancatori di parola nei confronti di Poseidone fu il re Laomedonte. Questi non mantenne la promessa di corrispondere al dio il giusto compenso per la realizzazione delle invalicabili mura di Troia. Un altro illustre spergiuro fu il semidio Minosse, suo nipote, figlio di Zeus e della regina Europa. Il re di Creta, dopo aver ricevuto uno splendido toro dal dio del mare col fine di sacrificarlo allo stesso al momento opportuno, venne meno al giuramento tenendo per sé il magnifico toro. Le esagerate reazioni del dio nei confronti del re di Troia e di Creta, dovettero rimanere fortemente impresse nell’immaginario collettivo dei posteri tanto da appellare il dio come colui che era “adirato per il giuramento non mantenuto” dalla controparte. Infatti l’appellativo Poseidone risulta formato dall’unione dei lessemi böse+eid+one (per la legge di Grimm sarebbe avvenuta la mutazione consonantica della b in p), che traducendo verbo pro verbum ci fornirebbe la sequenza dei lessemi, adirato+promessa+assenza o privazione. La libera interpretazione proposta è quella di arrabbiato per la promessa o il giuramento non mantenuto. Che il giuramento fosse vissuto dagli antichi come qualcosa che legava indissolubilmente due persone che venivano a patti, si evince nel lib. V, 180, dell’Odissea: “Ed è questo per gli dèi beati il gran giuramento e terribile”. Alla luce del passo citato, il vocabolo böse, cattivo, arrabbiato, può essere tradotto come terribile.
R
- RAFFAELE L’ARCANGELO.Il nome, composto dai lessemi Ref ed Hell, è un appellativo apposto all’arcangelo deputato ad accogliere le invocazioni dei malati. Il suo potere consiste nel guarire dai mali di cui chi lo evoca, soffre. Nella religione greca questo ufficio spettava al dio Apollo. Si sarà notato che entrambi i nomi di queste due entità, la cristiana da un lato, la pagana dall’altro, contengono il suffisso Hell. L’hell, nella mitologia norrena, prima che il cristianesimo operasse un sincretismo nei confronti del paganesimo nordico, al punto di travisare gli antichi significati del mito e dei luoghi, era il luogo compreso fra il Cielo e la Terra, lo spazio in cui circolavano libere energie extrafisiche, che uomini addestrati (sciamani, sacerdoti, maghi etc.) potevano captare e indirizzare in modo benefico. Con il termine Reff nella Lingua tedesca si indica la vela; questa ha la funzione di captare i venti, sfruttando dunque l’energia libera presente nello spazio (Hell).
- RASENNA. È il nome che gli Etruschi avevano dato a sé stessi. L’etimo potrebbe derivare dall’unione del termine germanico rahe antenna, pennone, con quello di ahne avi, antenati. Va infatti ricordato che una delle tre centurie di cavalieri istituite da Romolo dopo la fondazione dell’Urbe, che prendeva il suo nome, come afferma T. Livio, si chiamava Ramnense. Questo risulta formato da rahe e mn mente, intelligenza, memoria, ricordo. Dunque, con l’appellativo adottato da un categoria di etruschi che, probabilmente avevano un particolare ruolo sociale, i Rasenna, Rahe-es Ahne, si potrebbe aver fatto riferimento ad una categoria di individui che avrebbero posseduto la capacità di captare (rahe) i segni inviati dagli Avi (Ahne) attraverso la scienza dell’aruspicina
- RE. Vedasi voce ricco.
- RG-VEDA. Vedasi voce ricco.
- RICCO. Il significato italiano del lessema rich, di origine germanica, non diverge molto da quello rinvenibile nella lingua tedesca. Nella antica lingua germanica esso prevedeva una notevole gamma di sfumature, che andarono perdute nel periodo successivo a motivo del sopraggiungere di una sempre più accentuata divaricazione tra la dimensione del sacro e quella del profano. Rik o Rig, nella lingua parlata dai popoli del nord Europa, significava cerchio, anello, circolo. Il nome di persona Erik , En+rich o Her+Rik aveva il significato di il Signore del cerchio, il primo, il numero uno (EN), cioè colui che conduce, indirizza, dirige le forze racchiuse nel cerchio. Durante le adunanze si disponevano in cerchio i capi dei villaggi, che, in una prima fase delle antiche tradizioni indoeuropee, coincidevano con i più anziani, i saggi. I capi disposti in cerchio, evocavano gli dèi affinché questi partecipassero al consesso, o comunque ispirassero con la loro presenza i partecipanti perché prendessero le giuste decisioni per il bene della comunità. Il cerchio, di conseguenza, si caricava di potenti energie che risultavano pericolose per chi rimaneva fuori dal cerchio e protettrici per chi era all’interno di esso. Le costruzioni architettoniche che dovevano essere utilizzate per l’evocazione del sacro, o per ospitarlo, avevano dunque forma circolare in quanto ogni elemento del circolo doveva trovarsi equidistante dal centro in cui risiedeva la forza manifestata. Anche le prime città indoeuropee, come si evince dagli scavi archeologici che hanno fatto emergere la cerchia delle mura della città di Ebla in Siria, e la forma circolare del mundus a Roma, dovettero essere costruite all’interno di un muro circolare.L’Her+Rik, il signore del cerchio, il primus Inter pares tra i partecipanti al rito magico, divenne comunque designato come colui che aveva il compito di comunicare col divino a nome di tutti i partecipanti se non del popolo tutto, e il suo appellativo divenne sinonimo di pienezza e per metonimia di ricchezza poiché in lui confluivano i benefici elargiti dagli dèi. Successivamente il termine divenne sinonimo di re: Rex in latino, rajan in sanscrito, reiks in gotico. Dunque con il termine rix o Rig, si soleva indicare il sovrano consacrato, colui nel quale confluivano il potere politico e quello religioso, mentre con l’appellativo ancora in uso nella lingua tedesca per indicare il regnante, König (Konung nella lingua norrena), derivante da kuhn vacca, si indicava il capo politico, letteralmente il mandriano, con metaforico riferimento al capo popolo. Circa la sacralità attribuita al cerchio, essa è rinvenibile ancora nel rito del matrimonio, nel momento in cui l’unione tra gli sposi viene sancita attraverso l’inserimento nel dito anulare della fede o anello nuziale. L’anello unisce gli sposi nelle due dimensioni di sacro e profano. Per molto tempo, infatti, la famiglia, in cui marito e moglie erano equiparabili al sacerdote e alla sacerdotessa, venne considerata come un mondo invalicabile nel quale nessuno poteva interferire, neanche il re; fu soltanto durante il principato di Augusto che a Roma vennero introdotte leggi invasive nella vita familiare con grande indignazione dei Patres. Un altro esempio di associazione del cerchio al sacro, si ritrova nel titolo dato ad uno dei quattro libri Veda, il Rig-Veda, formato dai lessemi rig cerchio, Ve sacro e da con il significato di qui (in questo libro) nella accezione di immanenza.
- ROMA. È il nome della capitale d’Italia, fondata secondo la vulgata, il 21 Aprile del 753 a.C. Era convinzione di alcuni intellettuali dell’epoca augustea, quali Plinio per i Latini, Aristide e Plutarco per i Greci e molti altri, che la fondazione della città avesse origine divina e che fosse stata creata per essere da guida ai popoli della terra. Su questa base si è poggiata l’ipotesi di studio secondo la quale il nome celato di Roma possa essere quello di Amor, cioè il nome di Roma letto da destra verso sinistra, che era la direzione della scrittura dei popoli prima che i Greci ne invertissero la direzione, cioè in senso orario, adottata ancora oggi.
La pratica magica, praticata in alcuni ambienti della società di tanti popoli antichi, fra cui i Latini e successivamente i Romani, si basava sulla convinzione che tenere nascosto il primo nome di un uomo o della città patria, salvaguardasse dai danni di eventuali pratiche magiche ostili, tanto da condannare a morte chi avesse osato rivelarlo.
Tale cruenta precauzione, risulta plausibile con l’ipotesi avanzata da studiosi di esoterismo, secondo la quale in epoche remote, il rito, lo sciamanesimo, il sacerdozio, il simbolismo, l’alchimia, in una parola quella metafisica che tutte queste pratiche contempla, fosse alla base della cultura antica e della operatività di quelle antiche genti. La tesi verrebbe corroborata dalla ritualità con la quale si presiedeva alla fondazione di una città. Da questa emerge come l’uomo tradizionale credesse all’innesto del divino con l’umano attraverso la pratica dell’Evocatio. Se così viene dunque concepito quel mondo tradizionale, non meraviglierebbe se ogni atto creativo di quella cultura portasse seco un programma e un fine. Stando alla interpretazione metafisica della fondazione dell’Urbe, l’obiettivo che la nascita di Roma/Amor si poneva, consisteva nel cambio di paradigma fino ad allora presente in una società entrata in distonia con gli intenti del suo o suoi creatori. Per raggiungere il fine, bisognava creare un homo novus, portatore di frequenze armoniche, in sintonia con il “battito del cuore” dell’universo, frequenze che verrebbero create attraverso il sentimento dell’ Amor. Va notato che la fondazione di Roma descritta da Plutarco nella Vita di Romolo, mette in evidenza non solo la complessa parte rituale che accompagna la fondazione, ma il ruolo sacerdotale del fondatore che, con il suo carisma imprime una svolta alla società che sarebbe sorta entro il sacro perimetro della nuova città. La posizione altamente carismatica e, se vogliamo dirla in termini alchemici, l’opera in bianco che sta alla base della fondazione di Roma, viene completata dal secondo re, Numa, al quale si è concordi nell’attribuire caratteristiche sacerdotali; egli avrebbe fornito agli eredi che si sarebbero succeduti nella doppia veste di re e sacerdote, diciamo così, “l’alambicco”, l’ atanor, la pietra filosofale affinché l’opera al bianco potesse continuare nel tempo e che avrebbe agito a prescindere dalle reali capacità dell’alchimista; insomma, Numa avrebbe creato un meccanismo capace di riprodursi da sé, cioè autopoietico.
Che a Roma venisse praticata collateralmente alla religione ufficiale la tradizione magica, grazie a operatori “non ufficiali”, lo dimostrerebbe la discussa presenza di personaggi come Virgilio e Apuleio, additati dai loro contemporanei come non estranei ad ambienti in cui le antiche credenze non erano andate in disuso. Gli studiosi di esoterismo che sostengono la tesi secondo cui a Roma vi sarebbero stati fin dalla prima ora “alchimisti” o maghi che chiamar si vogliano, verrebbe tessuta sulla base etimologica ricavata dal nome della prima, per importanza, città latina di cui Roma/Amor sarebbe una costola: Alba Longa. Nel significato del nome alba, gli studiosi di esoterismo hanno visto la consapevolezza da parte degli ecisti, di quello che sarebbe stato un inizio sotto l’insegna e gli auspici della luce, rendendo l’idea di quella opera positiva che dai futuri alchimisti verrà indicata come al bianco, in contrapposizione alla magia nera o opera al nero attuata da individui guidati da forze disgregatrici. Continuando con le interpretazioni fornite in ambito esoterico, il passaggio del testimone da Alba Longa a Roma viene paragonato dagli esoteristi al passaggio delle consegne che Giovanni il Battista avrebbe attuato nei confronti di Gesù, facendo seguire le parole: “È bene che io diminuisca perché Lui cresca”.
Continuando in una lettura su base alchemica, gli esoteristi suppongono che, come un alchimista utilizzerebbe il simbolismo dei metalli per intraprendere l’opera, gli operatori del sacro o della magia, secondo il punto di vista o il lessico preferito dall’osservatore, a Roma abbiano coniato un lessico che non trova la medesima profondità semantica nel corrispettivo italiano quale cumpassio (compassione), justitia, aequitas, providentia, perché potesse risuonare una frequenza empatica con il suono emesso dal cuore dell’universo.
S
- SACERDOTE. Il Sacerdote è colui che attualizza il sacro. Il termine sacro entra dunque di diritto a far parte dell’etimo e i linguisti lo derivano da sacer. Poiché noi riteniamo essere germaniche le radici romane e della lingua latina, come abbiamo affermato in più occasioni (il rito druidico della fondazione di Roma, così come raccontato da Plutarco, la grammatica della lingua latina etc.) riteniamo che l’etimo sacerdote sia formato dall’accostamento del verbo sa’, conosciuto e Kern, nocciolo, centro, nucleo. Il termine indicherebbe l’individuo che possiede la conoscenza, conoscenza delle cose sacre che gli consente di poter mediare con il divino.
- SAGA. Dal verbo tedesco sagen dire, raccontare. Utilizzando questo sostantivo si vuole dare l’idea di trattare la storia romanzata di un popolo o di un personaggio. Le saghe hanno una origine nordica e il sostantivo deriva dal verbo tedesco sagen con il significato di dire, raccontare. Nelle corti medioevali gli Skaldi, equivalenti dell’ Aedo greco, erano incaricati di tramandare le saghe.
- SATURNO. Mitica divinità del Lazio (Virgilio Aen. IV, 6-6,41-XI,252). Il nome risulta formato dall’accostamento del lessema sat con il significato di sazio, abbondante, pieno e Ur che significa antico, primordiale. All’epoca di Saturno si faceva risalire la prima delle quattro età, quella aurea della pienezza e dell’abbondanza (Satya-yuga in sanscrito). Sarebbero seguite l’era dell’argento, del bronzo e del ferro. Varrone fa derivare il nome della divinità da ab Satus con cui si indica l’azione del seminare. Da un abbondante raccolto deriverebbe perciò, uno stato di certezza, di prosperità e felicità. L’Italia, come riporta Virgilio, prese il nome della divinità chiamandosi Saturnia Tellus. Dionigi di Alicarnasso conferma quanto asserito da Virgilio sostenendo che tutta l’Italia era sacra a questo nume. Gli storici antichi facevano derivare il toponimo Lazio, regione in cui Saturno era stato accolto dal dio Giano, dal verbo nascondere, mettersi da parte, latere appunto. Infatti nel Lazio si era nascosto Saturno che fuggiva da Giove. Si dovrebbe dare credito a quanto sostenuto dagli storici circa il significato del toponimo poiché anche Leto, la giovane madre mortale del dio Apollo, che fece perdere la testa all’incontinente Zeus, dovette nascondersi a Delo per sfuggire alle ire della gelosa Era. Leto, o Latona significherebbe dunque, la nascosta. Ancora, Lete era la fonte alla quale le anime che intendevano reincarnarsi bevevano per dimenticare; chi si nasconde lo fa nel tentativo di far perdere memoria di sé.
- SCELLERATO. Fu detta via scellerata quella in cui il re Servio Tullio fu gettato dal genero e sul cui corpo, la figlia Tullia, fece passare la propria biga in corsa. Il nome risulta formato da scee – sinistro, hell, spazio nell’accezione di sovrumano essendo l’hell nella mitologia germanica lo spazio tra cielo e terra dove albergano forze extrafisiche, e rat, consiglio. Lo scellerato è, dunque, come si evince dalla storia di Servio Tullio, colui che è attratto da un irrefrenabile istinto a seguire un impulso (rat) che proviene da entità superiori alle quali non si è in grado di resistere.
- SCETTICO. Lo scettico è colui che non ritiene possibile il verificarsi di azioni che per il suo metro di valutazione hanno del paradossale. Il vocabolo risulta formato dall’unione del lessema scee sinistro e akt atto, azione.
- SCEVOLA. È il soprannome apposto a Caio Mutio Cordio, un valoroso soldato romano, dopo che questi, avendo mancato di uccidere il re etrusco Porsenna scambiato con un servo, brucio sul braciere la propria destra rimanendo mancino. Scevola significa dunque mancino e scea veniva detta la porta della città di Arpinio, nei pressi di Roma, trovandosi posta alla sinistra delle mura.
- SELLI. È il nome dei sacerdoti di Zeus del santuario di Dodona (Iliade XVI, 235: “Profeti dai piedi sporchi, che dormono in terra”). Il significato del loro nome è rinvenibile nel ruolo da essi svolto come interpreti della volontà del Dio, il quale parlava a loro attraverso il rumore delle foglie della quercia mosse dal vento. Pertanto l’etimo risulta formato dai lessemi sa sapere, conoscenza, vedere, dal verbo tedesco sehen, e Hell con il quale si indicava lo spazio che sta tra il cielo e la terra. È probabile che Akille, rivolgendosi a Zeus dodoneo nel formulare il suo voto dopo la morte di Patroclo, fosse stato iniziato, come si deduce dal suo nome, da questi sacerdoti ai misteri (vedi voce Akille). Per i romani gli equivalenti dei sacerdoti Selli, erano i Sali, introdotti da Numa Pompilio secondo re di Roma.
- SICULO. Il nome risulta formato dal pronome riflessivo sich, sé , se stesso, attraverso il quale si intendeva sottolineare la stretta unione che il mandriano aveva con l’animale (la mucca, kuh in tedesco), da lui accudito, fonte di benessere e prosperità (nell’Avesta, il libro sacro dei Parsi, Zarathustra augura al re di ottenere molte mandrie). La medesima stretta identificazione avveniva per gli Sciiti e gli Unni con i loro cavalli, che non abbandonavano per nessuna ragione. Nell’immaginario collettivo questi indomiti cavalieri esotici, mangiavano e dormivano in groppa ai loro cavalli. Dunque i Siculi erano definiti i mandriani. Infatti, tra i popoli del mare, di cui facevano parte, essi vengono raffigurati nel tempio di Karnak, in Egitto, con un carro trainato da buoi. In senso metaforico, i re germanici furono definiti mandriani, in quanto erano chiamati a guidare popoli, perciò il re prese il nome di Konung, il mandriano. Se volessimo tracciare un parallelismo con le tribù di Israele, potremmo affermare che la tribù dei Siculi stava a quella di Giuda come quella dei Sicani (vedi voce sul glossario di miti3000.eu Pag. 159) stava a quella dei Leviti. Dalla prima provenivano i re, dalla seconda i sacerdoti.
- SIMBOLO. Secondo la vulgata, il termine simbolo dovrebbe derivare dal greco e sarebbe formato dall’unione dei lessemi syn e belein. Volendo fornire una alternativa interpretativa del lessema, si afferma che il termine possa derivare dall’unione dei lessemi germanici Sinn senso, sentimento, conoscenza e Bal signore. Il simbolo, seguendo quest’ultima etimologia, rappresenterebbe il linguaggio del divino, la modalità attraverso la quale il divino comunica alla parte immateriale, dell’uomo. Questo silenzioso linguaggio, proferito attraverso la visione del simbolo,, si baserebbe sulla intuizione, non sulla vibrazione prodotta dalle corde vocali con produzione di suono, ma da un indefinibile moto interiore che rivelerebbe un determinato significato, una conoscenza attraverso la muta percezione e/o intuizione.
T
- TAGES. È il nome del fanciullo che, secondo il mito etrusco, era nato dalla terra. L’infante avrebbe insegnato agli Etruschi molte delle loro arti. Il nome del fanciullo, nella lingua tedesca, ma anche in quella latina secondo la “lectio restituita”, scuola che si occupa del tentativo di restituire la pronuncia classica del latino, verrebbe pronunciato taghes. L’etimo, nella lingua tedesca, significa giorno. Non si può nascondere il sospetto, che nel mito etrusco si celasse, attraverso l’utilizzo letterario della metafora, il racconto di un cambiamento culturale apportato da una civiltà superiore dalla quale, gli Etruschi, in tempi mitici, avrebbero appreso le arti.
- TANAQUILLA. Era la moglie del futuro re di Roma Tarquinio Prisco. Era una ricchissima aristocratica etrusca. Il suo nome riconduce all’attributo ittita di Tawananna (vedi voce Anna Perenna) per indicare la regina madre. Il radicale Ana contenuto nel nome suggerisce che quello di Tanaquilla sia un attributo che caratterizza un aspetto della donna. Qual, nella lingua tedesca significa tormento. Nel mito che la riguarda, la regina appare un tipo tutt’altro che tranquillo.
- TARPEIA. È il nome della donna romana che venne corrotta dai Sabini, affinché aprisse le porte dell’Urbe assediata. Il nome è formato dall’unione dei lessemi tarn e peur. Tarn significa celato, nascosto; peur che significa fuoco, viene pronunciato nella lingua tedesca feur. Ebbene, la donna era una vestale, cioè una delle sacerdotessa deputate a custodire il fuoco sacro che rimaneva sempre acceso nel tempio di Vesta. L’appellativo apposto alla donna indicherebbe perciò, il fatto che essa celasse un fuoco interiore, infausto e contrario a quello che avrebbe dovuto custodire per il bene della Patria e che si manifestò attraverso il tradimento.
- TEUTO. È un nome proprio di persona. Si è però notato che si trova spesso, con le dovute varianti della lingua locale, a indicare re e governanti; Teuta regina dell’Illiria; Teutomato, re dei galli allobrogi, etc. È probabile che il nome sia stato in origine un appellativo che indicava il capo del popolo (Teutone?) . Infatti in sanscrito Touto significa popolo. Con il nome di Tuata de Dana si indicava il popolo della dea irlandese Dana. Nella epigrafe anellenica incisa in una stele di calcare ritrovata nei pressi della città di Adrano, in Sicilia, si legge chiaramente il lessema Touto. Recenti studi di ricercatori, hanno attribuito il su detto nome al principe di Innessa di cui parla Polieno nel suo trattato Stratagemmi. La città di Innessa, che successivamente, stando a Diodoro siculo, cambiò nome in Etna, è stata identificata dai ricercatori, con l’odierna città di Adrano.
- THUTMOSE. Nome appartenuto a tre faraoni vissuti a metà del II millennio a.C. Il nome Thutmose, risulta formato dall’unione dei lessemi tut, agire e maß misura, nell’accezione di equilibrio, di giusta misura, di agire nel modo corretto. Tenendo dunque conto che nella scelta del nome vi era implicito un programma, o un progetto da perseguire, esattamente come avviene per i papi della chiesa cristiana (nella scelta del nome Francesco si nasconde la volontà o il programma, in colui che lo assume, di ricondurre l’istituto alla primitiva povertà). I faraoni che scelsero di adottare il nome di Thutmose, miravano perciò, attraverso le loro opere ed azioni, a ristabilire o mantenere l’armonia, l’equilibrio, quello stesso ordine che gli dèi, quando governavano l’Egitto, avevano stabilito per il popolo egiziano. Che al lessema maß si debba attribuire il significato di misura, equilibrio, lo si deduce dal corrispettivo persiano Haura Mazda (vedi voce), la divinità definita da Zarathustra dio della misura (Il paganesimo di Gesù miti3000.eu). Infatti, il faraone Thutmose I salì al regno in un momento in cui l’Egitto era scosso da una serie di sedizioni dei popoli annessi. Il primo atto del Nostro, fu proprio quello di riportare l’ordine nel regno, come si evince dall’elenco dei popoli soggiogati trascritto nella stele rinvenuta presso Tombos. Il figlio Thutmose II, appena salito al trono, dovette reprimere anch’egli le sedizioni riprese in Nubia. Thutmose III non fu meno impegnato dei suoi predecessori a reggere l’equilibrio minato da un nuovo popolo apparso nei suoi confini, i Mitanni, i Mit-Ahne, i parenti, letteralmente quelli che si accompagnano agli Avi (vedi voce).
- TUSCI. È il nome con cui venivano chiamati gli Etruschi (T. Livio Ab Urbe condita). Il suffisso scee significa sinistro, mancino appellativo dato a Marco Muzio dopo che questi pose, rendendolo inutilizzabile alle armi, il suo braccio destro sulla brace, in seguito al suo fallimento dell’assassinio del re etrusco Porsenna. Ad Arpino, città non distante dai confini etruschi come li conosciamo in età storica, probabilmente più vasti in età pre storica, vi è una porta scea nelle antiche mura di cinta, così come una ve ne era a Troia la città sullo stretto dei Dardanelli che si vorrebbe essere stata fondata da Dardano proveniente dall’Etruria. Il suffisso sce si trova anche nel nome del popolo dei Volsci che secondo la modalità interpretativa da noi messa in atto, significherebbe il popolo sinistro, da volk popolo e sce sinistro. Volsci e Tusci dovettero rappresentare due rami del medesimo tronco.
- TUTANKHAMON.È il nome con cui è conosciuto l’erede del faraone Akhenaton, nonostante il suo vero appellativo fosse quello di Tutankhaton. Ebbe breve vita (1341 a.C. circa –1323 a.C. circa), per questo viene soprannominato il faraone bambino. Il nome risulta composto dall’unione dei lessemi Tut -An-Kam o ton se il riferimento è il nome precedente. Traducendo i lessemi verbum pro verbo, si ottiene la seguente sequenza: agire-cielo/avo-viene. È possibile ravvisare nel nome del faraone l’auspicio che egli, ancora giovinetto, al contrario del padre Akhenaton, considerato eretico dalla casta sacerdotale, divenisse, secondo le intenzioni della medesima casta sacerdotale, il vero vicario dell’Avo divinizzato (Anu) e agisse (taten) per ordine del Cielo e in sintonia coi dettami dell’Avo ( Cielo è sinonimo di Avo, An). In effetti, la prima azione compiuta dal faraone, o dai suoi tutori, i sacerdoti, una volta asceso al trono, fu quella di ripristinare l’antica religione politeista ridotta dal padre in monoteismo.
U
- UMBRIA. È il nome di una regione italiana. Ombros in greco. Umbras è la parola latina con cui Virgilio conclude l’Eneide, intendendo riferirsi al regno delle ombre o dei morti. La parola ombra riconduce anche al concetto di mistero, di qualcosa che rimane celato o visibile soltanto se ricercato, scrutato con la necessaria attenzione.
- UNI. È il nome di una divinità etrusca, l’equivalente della latina Giunone. Nella lingua tedesca il lessema un indica privazione, mancanza, assenza ma anche eccesso. Nella lingua tedesca, con l’espressione Un’abänderlichkeit si intende indicare l’immutabilita’, l’invariabilita’. Con riferimento alla lingua tedesca con il nome Unhold si indica lo stregone, lo spirito maligno, un essere malvagio. L’ipotesi interpretativa che maggiormente si presta, è quella di ritenere che l’appellativo Un fosse stato apposto alla dea che esprimeva un concetto di immutabilita’, o ciclicità degli eventi.
- UPPSALA. È il nome di una città della Svezia. Anticamente era la capitale del culto pagano – ancora oggi rappresenta l’area scandinava in cui vi è il più alto concentramento di pietre runiche- e proprio in questo luogo si trovava il tempio dedicato alla triade divina Odino, Thor, Freja. I re eletti dal popolo vi si recavano per essere incoronati e acclamati. Il nome della città è composto dal lessema ab (secondo la legge della mutazione consonantica proposta da Grimm, la B sarebbe stata pronunciata P) che indica provenienza, sottrazione, da sa, voce del verbo sehen, vedere, e alla che significa sia tutto che sala, grande stanza, un luogo molto spazioso. Il nome del luogo sacro, liberamente tradotto, significherebbe dunque, il luogo dove è depositata ogni conoscenza. Infatti, essendovi a Upsala il santuario in cui si svolgeva il culto nazionale, quest’ultimo doveva anche ospitare la casta sacerdotale detentrice del sapere. Il significato del nome che lo indica come luogo di deliberazione è depositario di conoscenze, sembra essere ancora giustificato dal fatto che una volta l’anno, tutte le tribù scandinave, si riunivano nella prateria di More’ per deliberare una politica comune sotto la vigile mediazione di un sacerdote Druida, prassi resistita fino alla cristianizzazione della Svezia avvenuta intorno all’XI sec. In questa occasione si svolgeva una una cerimonia religiosa nota come Dísablót.
- URLO. La radice Ur che forma il lemma, nella lingua germanica significa antico, primordiale. Nel caso in questione, l’etimo riconduce all’idea di una emanazione, di una liberazione di forze interiori represse verso l’esterno grazie ad un atto di espulsione vocale. L’urlo, oltre che rappresentare un atto spontaneo, liberatorio di tensioni interne, viene consciamente e sapientemente utilizzato come arma atta a terrorizzare il nemico. Tacito racconta infatti che, i Germani, scendendo in massa sul campo di battaglia, emanavano urla con tale potenza, che atterrivano le legioni. Quanto affermato da Tacito induce ad ipotizzare che il lemma sia formato dall’accostamento del lessema Ur a quello di alla, che significa tutti immaginando, stando a Tacito, una marea di individui che si riversa sulle legioni come un’onda sullo scoglio. Nel mito greco, il dio della natura Pan, libera Zeus dalla prigionia della mostruosa Delfine, emettendo un urlo che spaventa Delfine la quale, terrorizzata, fugge abbandonando il ruolo di carceraria. L’urlo viene emesso anche per manifestare l’atto di dominio su qualcosa o da chi reclama la propria sovranità. L’urlo rappresenta dunque la volontà 1di dominio del più forte, e, più potente è l’urlo emesso, maggiori sono le possibilità di imporsi.
V
- VEGONIA. È il nome della profetessa che ha rivelato agli Etruschi come interpretare il volere degli dèi, manifestato attraverso le folgori. Il suo nome deriverebbe però dal suo insegnamento sul come dividere i campi e contrassegnare i limiti; questi avrebbero assunto una valenza sacrale. Del libro che conteneva le raccomandazioni della profetessa, consegnato secondo la tradizione al re etrusco Arunte di Chiusi, ci sono pervenuti soltanto pochi frammenti. In uno di questi si legge: “Sappi che il Cielo è stato separato dalla Terra”, il frammento continua sostenendo che Giove aveva costituito i confini per le proprietà e chi li avesse spostati ne avrebbe pagato le conseguenze. A noi pare che il linguaggio metaforico della Sibilla facesse riferimento ai confini che dividevano il Cielo dalla Terra, l’elemento fisico dal metafisico, e che i confini da non intaccare cui ci si riferiva, erano quelli della tradizione atavica. Non bisognava cioè spostare i confini tra sacro, il Cielo, e il profano, la Terra. Il nome della Sibilla dunque, si riferirebbe al ruolo di garante che essa svolgeva, e sarebbe composto da Ve sacro e gonnen protezione nell’accezione di confine, recinto sacro invalicabile.
- VEIO. È il nome di una città etrusca al confine con il Lazio. Naturalmente i confini delle regioni italiane non erano i medesimi di oggi in tempi che sfuggono alla storia. Tra l’altro sappiamo quanto composita fosse la popolazione dell’Italia centrale prima della fondazione di Roma e fino a quando l’Urbe non unificò la penisola. L’assonanza del nome della città etrusca, con l’antica patria dei Persiani, Vaeja, cui fa riferimento Zarathustra nell’Avesta, ci permette di collegare al nostro studio la presenza di Germani in Persia al tempo di Ciro, come riporta Erodoto nella sua storia. In quel periodo nell’Italia centrale erano stanziati Sicani, Boi, Rutuli etc. , popoli, questi, germanici. Il nome della città risulta formato dall’accostamento dei lessemi Ve, sacro e jah, intuitivo, veloce, repentino rimandando all’idea di un luogo dove la presenza del divino è percepita rapidamente. Questo è il medesimo senso che Zarathustra nell’Avesta dava alla Vaeja, descrivendola come un paradiso terrestre da cui furono costretti ad emigrare, poiché il dio malvagio Angra Mainyu l’aveva sepolta in una “coltre di ghiaccio”. L’aggettivo jah intuitivo, repentino, caratterizza l’avo (Ano) dei Sicani del Lazio jah-Ano (Giano). Ancora nell’Avesta, il defunto, sottoposto alle prove dell’aldilà, doveva dare prova di possedere forza e abilità (jah).
- VERBO. Il termine verbo risulta formato dal prefisso sacro Ve (v. voce, miti3000.eu) e Bö. Con il termine Böen, nella lingua tedesca si indica una folata di vento improvviso e di breve durata, spesso accompagnato da grandine e/o pioggia. Con l’appellativo Böanerges (v. voce, miti3000.eu) venivano indicati gli apostoli Giacomo e Giovanni (v. voce). Il Vangelo di Giovanni dà ampia risonanza al termine tanto da identificare il Verbo con Dio. Pertanto si ritiene plausibile l’interpretazione del termine verbo, secondo la quale si indichi l’atto sacro del Pronunciamento, che determina la materializzazione e la comprensione di un pensiero astratto che altrimenti sarebbe rimasto inintelligibile.
- VERONA. È il nome di una città italiana che fa parte della regione Veneto. Il prefisso sacro Ve tradisce le origini galliche del toponimo. Verona potrebbe essere stata la città scelta come capitale religiosa o del sapere, dalla casta sacerdotale dei Druidi a cui spettava il compito di interpretare il significato delle sacre rune: Ve-runa.
Una ipotesi interpretativa alternativa a quella formulata, del nome Verona, potrebbe collegarsi al fiume che l’attraversa, l’Adige. Infatti con il termine Vara veniva indicato il corso di un fiume o in genere, le acque fluenti, comprese le fonti. È del resto notorio che i vichinghi svedesi venivano appellati vareghi, ovvero coloro che ‘vanno’ (gehen) sulle acque (Vara). Varuna, molto affine a quello della nostra città, era il nome della divinità delle acque che faceva parte del pantheon vedico. I Veda sono dei libri complementari all’Avesta, ora, nell’Avesta – Fargard I-, il libro sacro degli Irani, non sfugge la presenza del toponimo Varenna. Questo è il nome di una delle sedici terre create da Ahura Mazda, il dio persiano di Zarathustra. Erodoto, al tempo di Ciro (VI sec. a.C), individua in Persia, tra le tribù sottoposte al re, la presenza di quella dei Germani. Questa tribù germanica, affermatasi in Persia, avrebbe ben potuto essere quella che avrebbe coniato molti dei nomi germanici ivi presenti. Ancora nell’Avesta, Zarathustra, che ne compilo’ una parte, afferma che Ahura Mazda ordino a Yma, l’uomo scampato alla glaciazione della patria ariana, di creare un recinto, un Vara (una terra circondata da acqua?), dove condurre i sopravvissuti alla glaciazione. La cittadella sacra di Ur, in Mesopotamia, era costituita da una serie di edifici Templari eretti all’interno delle mura ed era circondata da un canale di acqua che fungeva da recinto. La città di Ur venne fondata intorno al IV millennio a.C. Riassumendo quanto sin qui esposto, dunque, Verona potrebbe indicare un luogo naturalmente recintato dallo scorrere delle acque del fiume, sia un luogo frequentato dai Druidi deputati alla interpretazione delle sacre rune. - VIRTÙ. Virtus in latino. L’aggettivo risulta formato dall’unione del lessema Ve, sacro e usa, casa (vedi la voce casa).
- VOLSCI. Vedi voce Tusci.
Z
- ZEUS.Mitica divinità greca, padre degli dèi. La sua dimora è l’Olimpo, un immaginario luogo collocato nel cielo di cui il Nostro è sovrano incontrastato. Nel mito biblico viene affermato che i figli degli dèi si unirono alle figlie degli uomini, abbandonando così la propria dimora, che era il cielo, per abitare sulla terra assieme alle donne, divenute le proprie compagne. Scegliendo di abbandonare il cielo per la terra, gli dèi, appellati nell’Antico Testamento – Salmi 82,1- Elohim cioè abitanti di Hell (vedi voce), persero l’immortalità.
È perciò plausibile che i figli degli dèi, gli Elohim, nome ebraico corrispondente ai mesopotamici Annunaki, la cui patria d’origine, come detto, era il cielo, abitando sulla terra, con il termine Zeus intendessero indicare, non senza un pizzico di nostalgia, la patria d’origine abitata dai propri Avi, gli immortali dèi. Infatti, il nome della maggiore divinità del pantheon greco, Zeus, risulta formato dall’unione dei lessemi zu, che significa verso, in direzione di, e hus (svedese hus; tedesco haus; dialetto del cantone Grigione usa etc.) che significa casa, dimora, patria. Pertanto zu+hus, la via verso casa, personificata in seguito dai poeti nel padre degli dèi, dovette nostalgicamente esprime l’antico ricordo di una perduta via “verso casa”, di una dimora abbandonata a cui gli uomini, discendenti degli dèi, ambiscono pur sempre fare ritorno.